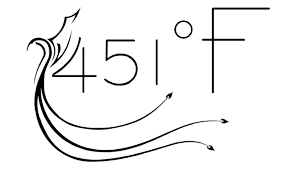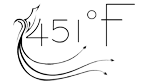Svetlana Aleksievič
Premio Nobel per la Letteratura 2015

“Per la sua scrittura polifonica e per un lavoro che è un monumento alla sofferenza e al coraggio del nostro tempo”. È questa la motivazione sottesa all’assegnazione del Nobel per la Letteratura alla giornalista e scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievič. Innumerevoli sono, infatti, le voci raccontate nel corso della sua vita in veste di cronista, testimoniando i principali eventi dell’Unione Sovietica della seconda metà del XX secolo. I suoi “romanzi testimonianza” o “romanzi collettivi” (dalla scrittrice stessa così definiti), per gli accenti particolarmente critici verso il regime dittatoriale in Bielorussia sono stati banditi dal Paese.
“Negli ultimi 30 o 40 anni Svetlana Aleksievič si è occupata della mappatura dell’individuo sovietico e post sovietico”, ha spiegato la presidente dell’Accademia del Nobel, Sara Danius, sottolineando come la sua non sia una storia fatta di eventi bensì di emozioni.
Depositaria di tante voci solitarie, le sue opere, riportando eventi storici, esplorano la dimensione introspettiva e individuale del singolo.
Una “ricostruzione non degli avvenimenti, ma dei sentimenti” attraverso le migliaia di interviste soprattutto a donne e bambini: come in War’s Unwomanly Face, Ragazzi di zinco, Preghiera per Chernobyl e come in Tempo di seconda mano. La vita in Russia dopo il crollo del comunismo, testimonianze della vita ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, della guerra in Afghanistan, dei sopravvissuti al più grande disastro ambientale della storia e del dramma dopo il crollo dell’Unione Sovietica.
Il discorso pronunciato dalla scrittrice bielorussa
alla cerimonia di conferimento del Nobel a Stoccolma
Io, l’orecchio di tante voci solitarie
Non sono da sola su questo palco… Ci sono voci intorno a me, centinaia di voci. Sono sempre state con me, fin dall’infanzia. Sono cresciuta in campagna. Quando eravamo bambini, adoravamo giocare all’aperto, ma quando calava la sera, le voci delle donne del villaggio che si radunavano stanche sulle panchine vicino alle loro case ci attiravano come calamite. Nessuna di loro aveva mariti, padri o fratelli. Non ricordo uomini nel nostro villaggio dopo la seconda guerra mondiale: durante il conflitto morì un bielorusso su quattro, combattendo al fronte oppure con i partigiani.
Dopo la guerra, noi bambini vivevamo in un mondo di donne. La cosa che ricordo meglio è che le donne parlavano d’amore, non di morte. Raccontavano di come avevano detto addio agli uomini che amavano il giorno prima che andassero in guerra, dicevano che li aspettavano e li stavano ancora aspettando. Erano passati anni, ma loro continuavano ad aspettare: «Non mi importa se è senza braccia e senza gambe, lo trasporterò io». Senza braccia… senza gambe… credo di aver saputo cos’è l’amore fin dall’infanzia (…)
Flaubert si definiva un uomo-penna; io potrei dire di essere una donna-orecchio. Quando cammino per strada e colgo parole, frasi ed esclamazioni, mi dico sempre: quanti romanzi spariscono senza lasciare traccia! Spariscono nell’oscurità. C’è tutta una parte della vita umana, quella delle conversazioni, che non riusciamo a cogliere attraverso la letteratura. Non l’apprezziamo per il suo valore, non ci stupisce, non ci appassiona. Ma a me affascina, ne sono rimasta prigioniera. Adoro il modo in cui parlano le persone… adoro le voci umane solitarie. È la cosa che amo di più, la mia passione.
La strada che mi ha portato fino a questo palco è stata lunga, quasi quarantanni, da una persona all’altra, da una voce all’altra. Non posso dire di essere stata sempre all’altezza di questo percorso. Molte volte sono rimasta sconvolta e terrorizzata dagli esseri umani. Ho provato ammirazione e repulsione. A volte volevo dimenticare quello che sentivo,tornare a un’epoca in cui vivevo nell’ignoranza. Ma più di una volta ho visto la bellezza sublime delle persone, e ho avuto voglia di piangere.
Vivevo in un Paese dove ci insegnavano a morire fin dall’infanzia. Ci insegnavano la morte. Ci dicevano che l’uomo esiste per dare tutto quello che ha, per bruciare vivo, per sacrificarsi. Ci insegnavano ad amare uomini armati. Se fossi cresciuta in un Paese diverso, non avrei potuto fare questo percorso. Il male è implacabile, devi essere vaccinata contro di esso. Noi siamo cresciuti fra carnefici e vittime. Anche se i nostri genitori vivevano nella paura e non ci raccontavano nulla – e spesso e volentieri non ci dicevano nulla – l’aria stessa della nostra vita era avvelenata. Il male ci spiava sempre. Ho scritto cinque libri, ma ho l’impressione che siano un libro solo. Un libro sulla storia di un’utopia (…)
Vent’anni fa, abbiamo preso congedo dall’«impero rosso» con lacrime e maledizioni. Ora possiamo guardare a quel passato con più calma, come a un esperimento storico. È importante, perché le discussioni sul socialismo non si sono mai esaurite. Una nuova generazione è cresciuta con un’immagine differente del mondo, ma molti giovani tornano a leggere Marx e Lenin. Nelle città russe si inaugurano musei dedicati a Stalin, si erigono monumenti in suo onore. L’impero rosso non c’è più, ma l’«uomo rosso» è sempre là. Continua a esistere.
Mio padre è morto poco tempo fa. Ha creduto nel comunismo fino alla fine. Conservava la sua tessera del partito. Non riesco a pronunciare la parola sovok, un appellativo denigratorio per la mentalità sovietica, perché sarei costretta ad applicarla a mio padre e ad altri che mi sono vicini, degli amici. Vengono tutti da lì, dal socialismo. Ci sono molti idealisti fra loro. Romantici. Oggi vengono chiamati a volte i romantici della schiavitù. Gli schiavi dell’utopia.Penso che tutti loro avrebbero potuto vivere una vita diversa, ma hanno vissuto una vita sovietica. Perché? Cerco da tempo la risposta a questa domanda, ho percorso in lungo e in largo l’enorme Paese che un tempo veniva chiamato Unione Sovietica, e ho fatto migliaia di registrazioni. Era il socialismo, ed era semplicemente la nostra vita.Ho raccolto pezzetto per pezzetto la storia del socialismo «domestico», «interiore ». Il modo in cui viveva nell’anima delle persone. Quello che mi attirava era quel piccolo spazio, l’essere umano, il singolo individuo. È lì, in realtà, che succede tutto. (…)
Quello che mi interessa sono le piccole persone. Le piccole grandi persone, potrei dire, perché la sofferenza le ingrandisce. Nei miei libri le persone raccontano le loro piccole storie, e allo stesso tempo raccontano la grande storia. Non abbiamo avuto il tempo di comprendere quello che ci è già successo e ci sta ancora succedendo, dobbiamo formularlo. Per cominciare, dobbiamo almeno formulare quello che è successo. Abbiamo paura di farlo, non siamo ancora in grado di misurarci con il nostro passato. Nei Demoni di Dostoevskij, Shatov dice a Stavrogin, all’inizio di una conversazione: «Noi siamo due esseri e ci siamo incontrati nell’infinito… per l’ultima volta al mondo. Lasciate il vostro tono e assumete un tono umano! Cercate di parlare almeno per una volta con una voce umana».
È più o meno così che cominciano le mie conversazioni con i miei personaggi. Certo, una persona parla partendo dalla sua epoca, non può parlare dal nulla. Ma è difficile raggiungere l’anima di un uomo, la strada è ingombra di quello che si sente alla televisione e si legge sui giornali, e delle superstizioni, dei pregiudizi e degli inganni della sua epoca. (…)
Che ci è successo quando l’impero è crollato? Prima il mondo era diviso in due: c’erano i carnefici e le vittime, era il Gulag; c’erano fratelli e sorelle, era la guerra. L’elettorato, era parte della tecnologia e del mondo contemporaneo. Il nostro mondo era diviso anche fra quelli che erano stati imprigionati e quelli che li avevano mandati in prigione, oggi c’è una divisione tra slavofili e filo-occidentali, «fascisti traditori» e patrioti. E tra quelli che possono comprare e quelli che non possono. Questa a mio parere è la più crudele delle traversie che sono seguite al socialismo, perché non molto tempo fa tutti erano uguali. Alla fine l’«uomo rosso» non è riuscito a entrare nel regno di libertà che sognava dal tavolo della sua cucina. La Russia è stata spartita senza di lui, e lui è rimasto senza nulla. Umiliato e defraudato. Aggressivo e pericoloso. (…)
Mi prendo la libertà di dire che ci siamo lasciati sfuggire l’opportunità che ci era stata data, negli anni novanta. Alla domanda «Che Paese vogliamo essere? Un Paese forte o un Paese degno, dove la gente possa vivere decentemente?», abbiamo scelto la prima alternativa, un Paese forte. Eccoci ritornati all’epoca della forza. I russi fanno la guerra agli ucraini. I loro fratelli. Mio padre è bielorusso, mia madre ucraina. Ed è così per tante persone. Gli aerei russi bombardano la Siria… Il tempo della speranza è stato rimpiazzato dal tempo della paura. Il tempo è tornato indietro.
Ho tre case: la mia terra bielorussa, la patria di mio padre dove ho vissuto tutta la vita; l’Ucraina, la patria di mia madre, dove sono nata; e la grande cultura russa, senza la quale non riesco a immaginarmi. Tutte mi sono molte care. Ma in quest’epoca, è difficile parlare d’amore.
(Pubblicato da La Repubblica l’8 dicembre 2015)