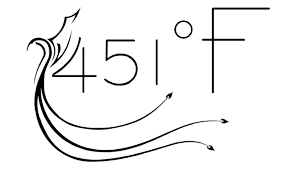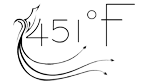Una donna
di Annie Ernaux
«C’è chi dice che la contraddizione
non si può pensare: ma essa nel dolore
del vivente è piuttosto una esistenza reale»
Hegel

«Mia madre è morta lunedì 7 aprile nella casa di riposo dell’ospedale di Pontoise, dove l’avevo portata due anni fa. Al telefono l’infermiere ha detto: “Sua madre si è spenta questa mattina, dopo aver fatto colazione”. Erano circa le dieci».
Un lutto è un lutto, indipendentemente dall’età che non funge da attenuante al dolore.
Scompare la persona più importante della tua vita, quella che ti ha dedicato la sua.
Quella che avverti come la prosecuzione delle tue braccia, delle tue gambe. L’origine emotiva del tuo cuore. Quella che ti conosceva più di tutti.
C’è chi reagisce.
Chi si perde.
C’è chi non riconosce più la propria vita colma di quell’assenza definitiva.
E c’è chi si dedica alla scrittura.
È la semantica dei rapporti, delle personalità.
Ha percorso quest’ultima strada Annie Ernaux nel 1986, quando su di un foglio bianco scrisse la frase che sarebbe divenuta l’incipit di Una donna.
Cercare la verità su sua madre, la donna reale esistente al di fuori della figlia, tratteggiando il suo ritratto e collocarlo nella storia attraverso le parole. Era questo il suo progetto.
Non una biografia né un romanzo, come dalla stessa acclarato, situandosi, forse, tra le pieghe della sociologia, della letteratura, della storia, appunto.
«Era necessario che mia madre, nata tra i dominati di un ambiente dal quale è voluta uscire, diventasse storia perché io mi sentissi meno sola e fasulla nel mondo dominante delle parole e delle idee in cui, secondo i suoi desideri, sono entrata».
Quello delle parole è l’unico modo e mondo, dunque, in cui la scrittrice francese in quel momento riesce ad esprimersi per affrontare il dolore, per alleviare i sensi di colpa, per ritrovare un ordine.
Dalla sua scomparsa ripercorre, così, l’intera vita della madre, nata nel 1906 nel quartiere contadino della piccola città normanna di Yvetot, a partire dall’infanzia attraversando il tempo che la vede bambina, la quarta di sei fratelli; poi ragazza operaia in una corderia; poi sposa; poi donna orgogliosamente commerciante di un bar-drogheria. La penna la dipinge forte, capace di superare ogni ostacolo, una donna che amava più donare che ricevere.
Affamata di cibo da bambina, di sapere da adulta.
Sono i tratti di un’esistenza costantemente connotata e mossa dal desiderio revanscista di evasione dalla miseria e dalla povertà in cui era nata, che affrontò, per affrancarvisi, impegnandosi indefessamente nel lavoro. Una condizione sociale da cui riscattarsi, responsabile dei suoi eccessi e della sua violenza.
«Tra tutti, era mia madre a portarsi dentro più violenza e orgoglio, una rivoltosa lucidità sulla sua posizione sociale di subalterna e il rifiuto di essere giudicata solo in base a quella».
Anche arricchire lo spirito imparando, apprendendo, rappresentò un mezzo per “elevarsi” che perseguì attraverso la lettura e attraverso il sapere e gli studi della figlia, alla quale tutto avrebbe dato, tutto quanto lei non aveva potuto avere. Questo il suo più profondo desiderio.
Poi, l’irreversibile ingresso della sua mente nel buio di una malattia degenerativa che riportò a ritroso le lancette del tempo all’infanzia: «uno spazio senza né stagioni né tempo solo la ripetizione di certe funzioni vitali», in cui, tuttavia, talvolta manifestò lucidità. Sempre, la voglia di vivere.
Schiaffeggiano le parole di Annie Ernaux nonostante il piglio del racconto, tra analessi e prolessi, sia quasi documentaristico, didascalico, laconico, all’apparenza distante emotivamente.
Schiaffeggiano per quello spazio di esulcerante identificazione in espressioni che solo la sensibilità legge: «Non sarà mai più in nessun luogo al mondo». (…) «Il buco di questo pensiero: la primavera che non vedrà».
Schiaffeggiano i ricordi. Quello dell’ultima sua immagine felice. Schiaffeggiano i dettagli: come quello delle sue mani, grandi, fissate da due obiettivi fotografici cronologicamente distanti. Schiaffeggiano le sensazioni: «Per un istante, pur essendo pienamente cosciente della sua morte, mi aspetto di vederla scendere le scale per sistemarsi in soggiorno con la sua scatola da cucito. Questa sensazione, nella quale la presenza illusoria di mia madre è più forte della sua assenza reale, dev’essere la prima forma dell’oblio».
Una donna (L’Orma editore) è un doloroso memoir la cui deliberata asetticità, la medesima del Patrimonio rothiano, adottata per conferire valore storico e reale ad un evento, urla con potenza l’amore verso la donna più importante della sua vita. Quella che lentamente, mentre la penna è al termine del proprio volere, sta assumendo le fattezze di «un’ombra larga e bianca sopra di lei», l’immagine che aveva nella sua prima infanzia.
«Non ascolterò più la sua voce. Era lei, le sue parole, le sue mani, i suoi gesti, la sua maniera di ridere e camminare, a unire la donna che sono alla bambina che sono stata. Ho perso l’ultimo legame con il mondo da cui provengo».
Era necessario che sua madre diventasse storia, sì.
E non vi è omaggio più commovente.