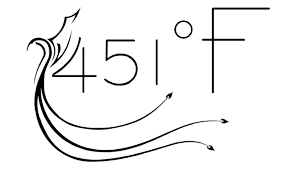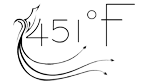Trilogia della pianura
di Kent Haruf
“Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza.
Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza.
I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi,
la bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi.
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto.
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono.
Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
Ti salverò da ogni malinconia,
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te…
io sì, che avrò cura di te”
La cura
Franco Battiato
Non è un popolo perso e senza speranza, alla spasmodica ricerca di un usbergo e di una pace irraggiungibili, di cui la polvere del Colorado di John Fante è testimone. Quello di Kent Haruf nella Trilogia della pianura (NN Editore) è un popolo con una propria appagante collocazione naturale, anche nella sconcertante e disarmante semplicità e nell’ineluttabile normalità. Affreschi realistici dipinti da differenti registri stilistici, ora piani e asciutti ora barocchi e articolati, contemperando il lirismo alla precisa crudezza di alcune immagini.
Come la profondità di un commiato, quello di Dad Lewis. La sua agonia, la sua “lotta contro la specie”, come direbbe Umberto Galimberti, dura il tempo dei saluti degli amici, del commosso congedo da una routine totalizzante e dell’onirica riconciliazione con i fantasmi di una vita lontana. Come la miracolosa perfezione di una nascita, la figlia della giovane Victoria Roubideaux la cui presenza amorevolmente altera l’ordine dei vecchi, burberi, malmostosi, ma anche comici fratelli McPheron.
“Ha bisogno di una casa per questi mesi. E anche voi – sorrise – dannati vecchi solitari, avete bisogno di qualcuno. Qualcuno o qualcosa di cui prendervi cura, per cui preoccuparvi, oltre a una vecchia vacca fulva. C’è troppa solitudine qui. Prima o poi morirete senza aver avuto neppure un problema in vita vostra. Non del tipo giusto, comunque. Questa è la vostra occasione.”
Occhi negli occhi, ha soltanto il tempo di stringere la mano del fratello, invece il vecchio Harold, vittima di una furia belluina.
E come la pudica gioia di una nuova amicizia, quella tra Dj e Dena; lo sgomento e l’eccitazione della scoperta di Ike e Bobby, i figli del fidato professor Tom Guthrie; la retriva cultura dominante confliggente con l’iconoclasta reverendo Lyle e l’ignoranza e la povertà, in rari casi anche d’animo, contraltari al valore, spontaneo e subitaneo, “del curarsi di”, “del prendersi cura dell’altro”, pervasivo la loose trilogy.
Quella “gentilezza e dolcezza reciproche tra le persone. Lo scorrere lento del tempo in una notte d’estate. La vita normale”.
Normalità e cura dell’altro.
Normalità è cura dell’altro.
Preziose destinazioni (per chi non vi fosse già approdato). Come preziosa è la loro luce, riverbero e parte stessa di altro fulgore.
Ogni libro possiede una luce propria. Quella, corale, di Benedizione, Canto della pianura e Crepuscolo – rispettivamente Volumi 1, 2 e 3 – è il lucore di Holt. La fantomatica contea del Colorado, dove le vite della pletora di personaggi doppiati da Haruf, scontrandosi, intrecciandosi e sfiorandosi, sono accompagnate da una semplice e sobria melodia musicale narrativa.
La luce guizza e danza. Fredda al mattino, è falsa nel tardo pomeriggio.
Obliqua penetra e colpisce replicando ombre filiformi.
Nei fanali delle automobili fa brillare, come granelli d’oro, la polvere che il vento si diverte a mulinare.
Azzurra e blu è quella dei lampioni che puntellano i campi bui della sconfinata e brulla pianura –cornice di Holt – metodicamente disegnata da un reticolato di strade, con i pascoli bruni, le stoppie scure del frumento e i crocifissi dei pali del telefono; è quella che illumina le ampie vie della città, fiancheggiate da olmi, robinie, bagolari e sempreverdi, dove le case, se a sud, sono a due piani, con prato e garage privati, se a nord, verniciate di blu, giallo o verde pallido con annessi pollai, cani alla catena e carcasse di automobili arrugginite.
Ed un pomeriggio di fine autunno, un’ora prima del Crepuscolo, improvvisamente è la luce aspra, tagliente e abbacinante di un proditorio sole allo zenit in un giorno d’estate.