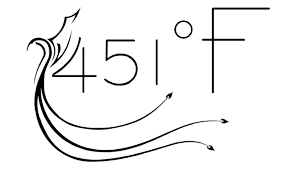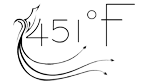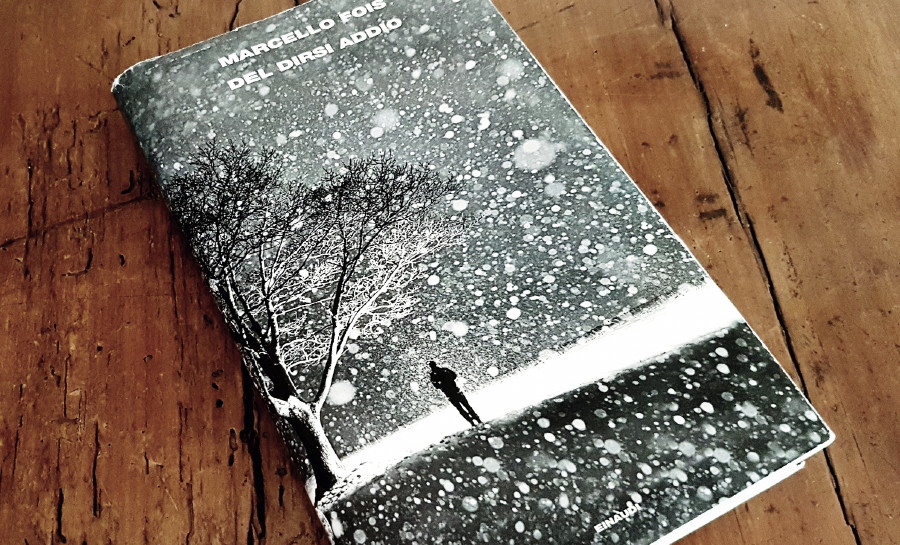Del dirsi addio
di Marcello Fois
“(…) Tutto lì. Un angolo color avorio dove forse avrebbero potuto trovare spazio visioni e apparizioni , ma che ora rivelava solo l’immensa precisione con cui si muore. Con quel gesto, di cui non si sarebbe mai pentito, acquistò una competenza della fine, una capacità di disillusione, una dimestichezza col prosaico che gli sarebbero state molto utili”.
È risibile, imbarazzante, lo spazio televisivo dedicato ai libri. Come quello a mezzanotte all’interno di un contenitore di approfondimento dei principali accadimenti del giorno in cui quest’estate è stato presentato Del dirsi addio.
Un’attenzione inevitabilmente asettica all’oggetto in questione.
Eppure nell’ultimo romanzo di Marcello Fois c’è tanto.
Da leggere. Tanto da sentire.
Se Helen Phillps, con cui Fois dialogherà l’8 settembre in occasione della XXI edizione del Festivaletteratura di Mantova durante l’incontro “Le cose non sono mai come appaiono“, nelle proprie opere dosa umano e divino, luce e penombra, anche l’autore sardo ora gioca con l’ambiguità, con i chiaroscuri dei quattro elementi accostando la classicità – un omaggio dallo stesso acclarato – alla modernità e al genere thriller cui ritorna. Non sempre, infatti, la luce chiarisce lasciando bensì il compito all’oscurità che disvela pieghe nascoste dall’evidenza.
“Nel regno dell’aria questo è un principio assodato: troppa chiarezza, come troppa oscurità, confonde. La verità sussiste in una luminosità mediocre, non troppo buio che sottrae, non troppa luce che moltiplica. Non l’assenza di particolari del buio pesto, non l’eccesso di particolari della luce piena.”
C’è tanto, dunque.
Nel giallo imbiancato dalla neve di una Bolzano siderale e diafana, con frequenti incursioni memoriali nella Dotta Bologna, c’è un caso da risolvere per il commissario Sergio Striggio, la scomparsa di un bambino affetto dalla sindrome di Asperger. C’è un apparente, un presunto segreto, quello proverbiale di Pulcinella (avendo i genitori un sesto senso), ossia l’omosessualità di un figlio. Ci sono i quattro elementi, quasi immoti nel loro eterno e potente movimento, mentre esercitano un ascendente sulla vita dei protagonisti cadenzando le parti di cui la storia si compone: la Terra, con la durezza del proprio nome sotterraneo e la morbidezza del proprio nome terrestre; il Fuoco che sovrintende il rapporto di paternità (“Ogni padre è tre fuochi insieme: quello dell’accoglienza, quello del sacrificio, quello della vendetta. I figli guardano ai padri esattamente nelle tre accezioni: compagni accoglienti delle madri, fumosi e sfuggenti, inflessibili e punitori”); l’Acqua che permette a taluni di adattarsi alle difficoltà mediante una mutazione del respiro; l’Aria (detentrice del primato su tutti per vigore) che non concede riposo agitando i pensieri. (“Un continuo rimescolare , ripensare, ricostruire, rimettere in gioco, guardare da prospettive inaspettate”.)
C’è la natura, onnipresente nelle diegesi foisiane. Una natura messaggera, dolce e brutale al contempo.
“Erano stati tempi strani quelli. Colmi di attese e di successivi disincanti, perché tutto quanto appariva come semplicemente noto: il raggio radente, la sfera di brina, la foglia flessuosa, il punto cangiante del cielo, la linea tremula dell’orizzonte, il canto dell’acqua… Tutto, tutto improvvisamente si rivelava meraviglioso. Ragionevolmente miracoloso, come qualcosa di cui sappiamo tutto senza saperlo.”
E c’è la sua declinazione più magica: la neve. Sfondo dal candore abbacinante capace di ipnotizzare e di scatenare “inarrestabili associazioni a catena” nell’intera narrazione.
« “Non è a me che devi dire addio. Il punto non è mai dire addio”, scandì sua madre all’improvviso, con una chiarezza nella voce che lo aveva fatto tremare.
“E qual è il punto?” aveva osato chiederle. Lei lo aveva fissato come se non riuscisse a riafferrare il filo del discorso interrotto qualche secondo prima. “Hai detto che il punto non è mai dire addio”.
La madre lo guardò grata per quel breve riassunto. “Il punto è dirsi addio”, rispose.
E lui capì perfettamente.
Intanto si era messo a nevicare con un impeto solenne. Come succede nei romanzi russi, nei quadri romantici e nei poemi artici.
Cominciò a nevicare con l’ostinazione di chi vuole fare chiarezza, ma ottiene solo di ricoprire tutto di un candore definitivo.»
E ci sono le atmosfere. Sinestesiche, evocative e tanto feroci da morire per un eccesso di emotività. Atmosfere che emettono un calore estraneo, un afflato di depressione, che esprimono “una immobilità e lucidità hopperiane“, e quasi dotate di proprietà organolettiche. Come quella del tramonto, “la piccola morte”.
“In quell’ora mediana e detestabile, di passaggio, né buio né luce, l’umanità tratteneva il respiro e il cuore cominciava a pompare senza controllo, e in gola si sentiva un sapore aspro, acre, d’attesa, appunto. L’aria virò all’ambrato intenso, come avviene quando si deve constatare che un giorno sta finendo. (…) Quella precisa malinconia aveva anche un sapore, che era acre, di pietra e vento. E un colore, che era un preciso tono di arancio brunito, come la scheggia d’ambra che imprigiona l’insetto primordiale. E un suono vibrante e preciso anch’esso, bordone d’aria compatta che scivola a valle penetrando tra le fessure dei monti. Oh aveva una precisa consistenza al tatto quel sentimento, era come sfiorare la superficie fredda di un piano di marmo levigato.”
Ci sono le categorie del “dubbio” e quelle della “certezza”, degli anthropoi e degli andres.
C’è chi approssimandosi alla fine – Pietro Striggio – invoca la smemoratezza e quella stagione della vita passata priva di gravità e governata dalla levità. “Perché la felicità non è nient’altro che leggerezza… propensione al volo.”
E c’è chi con colui che sta congedandosi ha sempre ingaggiato lotte greco-romane, “solenni e raffinate nel tempo” dichiarazioni di guerra: Sergio Striggio, “figlio d’arte”, acuto, apparentemente presuntuoso, dalla formazione classica, diffidente verso l’eccessiva felicità, abile nel fare distinzioni (“da sempre la sua maledizione“), tormentato e convinto degli estremismi dell’amore come la cecità, l’indomabilità, la temerarietà, la puntigliosità, l’atrocità (“Tutto il resto è un regalo, una vacanza”).
Con prosa elegante, introspettiva e centrata, Marcello Fois indaga gli animi e i rapporti umani, giovani e adulti con i loro pregressi stratificati, sedimentati, calcificati, fatti di incomprensioni e fraintendimenti. Come quelli tra genitori e figli, tra amanti, compagni, come quelli tra colleghi.
La narrazione che viaggia su due binari paralleli, quello privato e quello professionale del Commissario, deraglia intersecando entrambe le traiettorie. E mentre il mistero si scioglie, non senza colpi di scena, si spiegano anche i nodi umani, grumi di sangue e lacrime annosi e latenti, espressivamente predominanti e maggiormente toccanti.
E ci sono una commovente profondità e una tensione emotiva, rimosse, trattenute poi berciate nell’intimo a fior di labbra e sardonicamente ironizzate che riverberano reminiscenze di aspettative, di desideri, di progetti, e che esulcerano la prossimità dell’abbandono e del distacco.
E, poi… infine… quindi, ci sono gli addii.
Quando occorre imparare a dirsi addio? Secondo Marcello Fois al più presto, e una ricerca che si risolve nell’ordinario – uno squallido punto di congiunzione tra la parete e il soffitto – suggerisce il “come”:
“Si sarebbe messo tra il bosco e il letto per riempire l’ultimo sguardo e avrebbe sorriso, perché come ci si dice addio è la cosa più importante del dirsi addio.”
“(…) E tutto questo per avere la certezza di poter vedere esattamente l’ultima cosa che lei avrebbe visto prima di morire. Così si rese conto che da quella posizione si vedeva solo una porzione assolutamente ininfluente del punto di congiunzione tra la parete e il soffitto. Tutto lì. Un angolo color avorio dove forse avrebbero potuto trovare spazio visioni e apparizioni , ma che ora rivelava solo l’immensa precisione con cui si muore. Con quel gesto, di cui non si sarebbe mai pentito, acquistò una competenza della fine, una capacità di disillusione, una dimestichezza col prosaico che gli sarebbero state molto utili”.