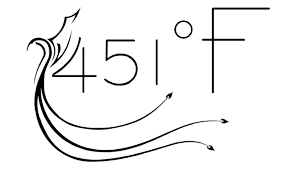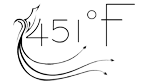PATRIMONIO. Una storia Vera
di Philip Roth
[Newark ~ 19 marzo 1933]
“La sua tazza aveva l’aura di un reperto archeologico,
un manufatto che indicava un inatteso livello di raffinatezza culturale,
un eccesso stupefacente in un’esistenza per il resto limitata e chiusa:
nel nostro ordinario bagnetto di Newark essa ebbe su di me l’impatto di un vaso greco che raffigurasse le mitiche origini della razza.”
 Sono lontani i dissacranti alter ego. Il gioco dell’ambiguità tra finzione e realtà, quello dello scambio tra vita e arte si sono presi una tregua.
Sono lontani i dissacranti alter ego. Il gioco dell’ambiguità tra finzione e realtà, quello dello scambio tra vita e arte si sono presi una tregua.
Nudo, spoglio delle sue maschere seriali, Philip Roth in Patrimonio – Una storia vera, attraverso una prosa altrettanto spoglia e piana (talvolta anche brutale), ripercorre il calvario del padre colpito da un male incurabile, un tumore al cervello, accompagnandolo e accudendolo in ogni suo più intimo e drammatico istante.
Lungi da qualsiasi intento esibizionistico, autocommiserativo o autoreferenzialista, ma spinto da un’urgenza personale da assecondare, ora il Roth cinquantacinquenne racconta il Roth ottantaseienne: l’assicuratore in pensione con una licenza media rilasciata dalla Thirteenth Avenue School di Newark; l’uomo difficile, brusco, integralista della disciplina, ardente antirepubblicano, l’uomo tetragono dall’ossessiva caparbia sino a spingere la moglie (scomparsa da sei anni) a rasentare un esaurimento nervoso, ma dalla concreta franchezza che rimaneva impressa “come autentico fascino in persone di ogni genere”; il fiero membro di quell’associazione famigliare organizzatasi nel 1939 a Boston e a Newark. La stessa Newark inesauribile fucina di aneddoti e ricordi, ora, purtroppo, sconnessi, e parte destinata, insieme con le “deiezioni” paterne e con l’unico cimelio superstite degli anni dell’immigrazione (una tazza per farsi la barba), ad entrare a pieno titolo nel Patrimonio, ideale e materiale, che titola la storia. Vera, come recita il sottotitolo. Esulcerante. Penetrante. Commovente. Empatica.
“Smascherato” e non lesinando in una doviziosa descrizione di dettagli, Philip Roth in questo breve romanzo autobiografico tra scoramento, dolore, paura e infinito amore lotta al fianco del padre, un Hermann Roth che con pugnacia e dignità affronta quanto lo attende, sentendosi ora più che mai a lui legato, intrecciato in una condizione di inquietante intercambiabilità.
“Sulla credenza di fronte al sofà c’era l’ingrandimento dell’istantanea scattata cinquantadue anni prima con una macchina fotografica a cassetta sulla costa del New Jersey che anche noi, mio fratello e io, avevamo incorniciato e messo bene in vista nelle nostre case. Siamo in posa, in costume da bagno, un Roth dietro l’altro, sul prato antistante la pensione di Bradley Beach dove la nostra famiglia affittava una camera da letto con uso cucina ogni estate per un mese. È l’agosto 1937. Abbiamo quattro, nove e trentasei anni. Ci drizziamo verso il cielo formando una V, di cui i miei sandaletti sono la base appuntita e le spalle larghe di mio padre – tra le quali è perfettamente centrata la faccia furba da folletto di Sandy – le due imponenti terminazioni della lettera. Sì, quella che spicca sulla fotografia è la V di Vittoria: di Vittoria, di Vacanza, di retta e distesa Verticalità! Eccola, la linea maschile, intatta e felice, in ascesa dalla nascita alla maturità!
Unire in una sola immagine la robusta solidità dell’uomo nella foto con lo sfinimento dell’uomo sul divano era e non era un’impossibilità. Cercare con tutta la mia forza mentale di unire i due padri e farne una cosa sola era un’operazione sconcertante, infernale addirittura.”
Nonostante la sensazione di intercambiabilità, vive, quindi, tuttora nella mente rothiana quella (toccante) verticalità generazionale non ancora spodestata dall’odierna orizzontalità dei ruoli, fonte di scompensi, insoddisfazioni e frustrazioni. Una verticalità connotante la sua intera produzione letteraria.
Ai detrattori che biasimano lo scrittore americano per la ripetitività dei temi trattati, si ricordino le parole di Alessandro Piperno (suo inveterato ammiratore) nel rimarcare come la sua unità di misura sia sempre stata la famiglia: “Conoscete nucleo sociale più commovente della famiglia?”.
“Dopodiché, non potei fare altro che seguire la lettiga fino alla stanza dove lo collocarono e sedermi al suo capezzale. Morire è un lavoro e lui era un gran lavoratore. Morire è orribile e mio padre stava morendo. Gli tenni la mano, che almeno sembrava ancora la sua mano; gli carezzai la fronte, che almeno sembrava ancora la sua fronte; e gli dissi cose di ogni genere che non era più in grado di sentire. Per fortuna, di ciò che gli dissi quel mattino non c’era nulla che non sapesse già.”