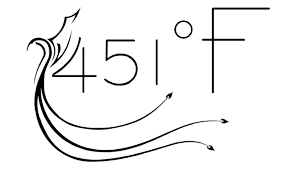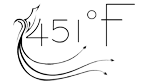Piccolo Trattato di Consolazione ~ Vivere con i nostri morti
di Delphine Horvilleur
Traduzione di Elena Loewenthal
«Per contro, so bene che col tempo ho adottato alcuni riti o abitudini che potrebbero essere scambiati per gesti apotropaici quando non disturbi ossessivo-compulsivi e che in un modo decisamente arbitrario mi aiutano ad arginare lo spazio della morte nella mia esistenza.
Di ritorno dal cimitero, ad esempio, non rientro mai direttamente a casa.
Dopo una sepoltura mi impongo sempre una deviazione per un caffè, un salto in un negozio, qualunque altra cosa. Creo una barriera simbolica fra la morte e casa mia.
Di portarla da me non se ne parla nemmeno. Devo a tutti i costi seminarla, lasciarla altrove, accanto a una tazza di caffè, in un museo o un camerino, e accertarmi dunque che abbia perso le mie tracce e che, soprattutto, non conosca il mio indirizzo»
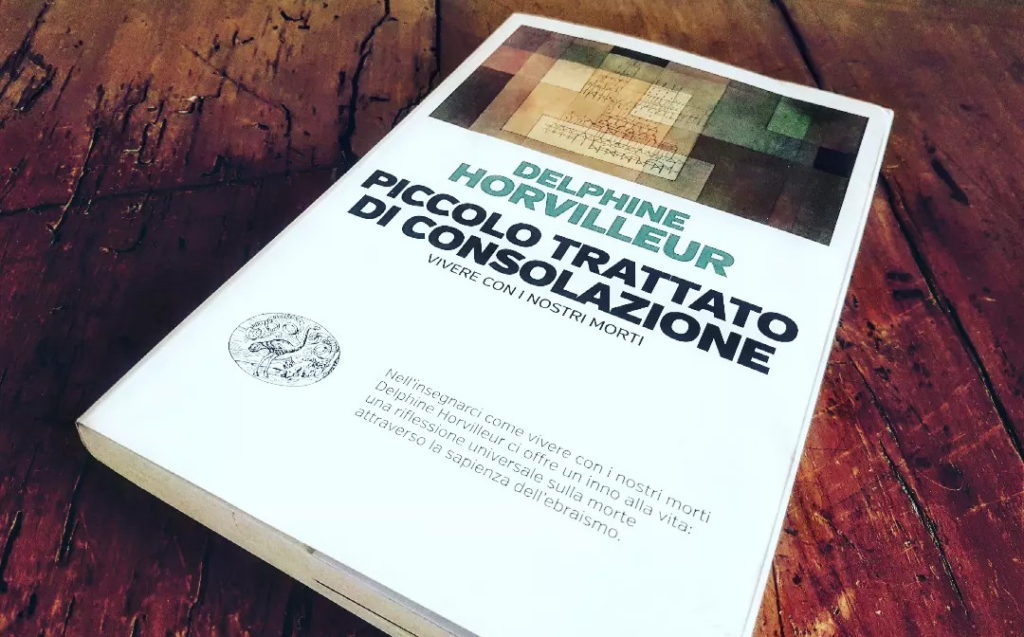
«Non ti turba essere a così stretto contatto con la morte? Non è faticoso trovarsi così spesso accanto a delle persone in lutto?». Sono le domande più frequenti che si sente rivolgere la rabbina francese Delphine Horvilleur.
Schiva le domande con risposte aleatorie, ma la verità è che non lo sa: «Né sono in grado di spiegare l’effetto che fa su di me, visto che non ho idea di che donna sarei se mi fossi premurata di tenermene lontana», afferma infatti.
In “Piccolo trattato di consolazione. Vivere con i nostri morti” (Einaudi), riflettendo sulla morte, Delphine Horvilleur delinea un commovente inno alla vita attraverso la descrizione liturgica della sapienza ebraica, grazie ai testi del Talmud, alle parole della Torah, alla tradizione rabbinica. Un ecumenico e prezioso insegnamento che trascende dalla confessione di chi si approccia al testo e da cui poter attingere una riflessione escatologica.
Essere una rabbina per Delphine Horvilleur significa, soprattutto, trovare la postura verbale e gestuale più appropriata per reagire all’apparizione della morte. Significa essere un’ascoltatrice, prima, una narratrice, poi, di quelle parole da pronunciare mentre accompagna al cimitero coloro che hanno perduto una persona cara. Parole intime, personali, riferite da chi è in lutto, e che, ora, necessita di ascoltare come se fosse la prima volta, affinché decodifichi la propria storia, affinché getti un ponte, un varco fra le generazioni. Fra coloro che sono stati e coloro che saranno. Fra i vivi e i morti.
E stare sulla soglia della porta, a garanzia che resti aperta, è il ruolo del narratore. Curarsi della volontà del defunto, ma ancor prima riconoscere ai suoi cari la possibilità di sopravvivergli e di onorare degnamente la sua memoria è, dunque, il più grande rispetto a lui riconosciuto e quella porta ne è il simbolo.
Raccontando undici storie, di cui è stata protagonista, la rabbina di Judaisme en Mouvement illustra, così, il significato della preghiera “Qaddish”; la figura di “Azral”; le origini dell’ironia ebraica; la portata simbolica del sasso posato sulla tomba, sinonimo di filiazione; il “Qadosh”, il tempo sacro, ossia “separato”, nel quale entra chi sopravvive alla scomparsa di una persona; la “generazione”, “Dor”, che rappresenta la fila di una cesta intrecciata, aggrappata alla forza di quella che la precede anticipando il consolidamento della successiva; lo “Shakul”, il genitore che ha perso un figlio; “Olam hazeh”, l’universo nel quale si vive e “Olam haba”, quello al quale si approda; la leggenda sulla morte di Mosè; il significato di “Abracadabra” (“ha fatto come ha detto“), quello di “shakul“; il “mezuzah”, l’astuccio legato alla capacità di abitare un luogo dove anche la mancanza trova posto.
E poi, il cimitero. Delphine Horvilleur espone come il suo nome in ebraico, “beit ha-chayim”, letteralmente “casa della vita” o “casa dei vivi”, non evochi una negazione della morte bensì una convocazione della vita, che è onnipresente.
È questo, infatti, l’impegno, solenne, che gli ebrei si assumono al momento del passaggio: «fare sì che qualcosa di colui che se ne va resti e sopravviva ed integri la loro vita per fare parte di ciò che saranno in futuro»… anche nell’atto di sollevare i calici, al grido di “Lechayim!”, “Alla vita!”.
«È possibile imparare a morire? Sì, a condizione di non rinnegare la paura, di essere pronti, come Mosè, a voltarsi indietro per vedere il futuro. Il futuro non è davanti a noi, bensì alle nostre spalle, nelle tracce dei nostri passi sul suolo di una montagna appena scalata, tracce nelle quali coloro che verranno dopo di noi e ci sopravvivranno avranno modo di leggere quel che a noi non è ancora stato dato di vedere.
Gli ebrei sostengono di non sapere quel che c’è dopo la nostra morte. Però potrebbero anche dirla diversamente: dopo la nostra morte, c’è quel che non sappiamo.
C’è quel che a noi non è ancora stato svelato, quel che gli altri faranno, diranno e racconteranno meglio di noi, perché noi siamo stati».