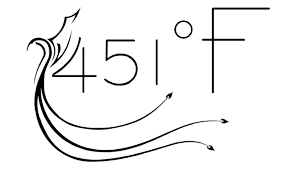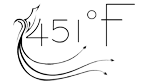Vita mortale e immortale della bambina di Milano
di Domenico Starnone
«Che c’è. Che succede, chi t’ha fatto dispiacere.
Nisciuno.
E allora perché vuomurì.
Le avevo risposto che non volevo morire, volevo solo starmene un poco morto e poi alzarmi. […]
Fu allora che, allo scopo di farmi capire che sottoterra non si stava bene,
mi parlò per la prima volta della fossa dei morti.»

«Le volevo bene, questo sì, ma c’erano altre cose che, più di lei, mi riempivano il cervello e mi smuovevano i sentimenti. Gliele elencai: la lettura, la scrittura e la morte.
“Ho un desiderio di vita, no’, così violento che la vita la sento continuamente in pericolo e la voglio trattenere in tutti i modi per non farla scivolare via e finire; è una smania che m’è entrata qua nel petto, credo, quando è morta la bambina che giocava al balcone al secondo piano del palazzo celeste di fronte al nostro”.
E a quel punto, per essere sicuro che avesse capito, le chiesi:
“Te la ricordi la bambina di Milano?”
“Quale bambina di Milano?”».
Napoli. Anni Sessanta. Un bambino di otto anni si innamora di una graziosa figurina che volteggia nell’aria. Gioca a fare la ballerina di carillon. Così audace nei saltelli e così esposta alla morte, se cadesse, quel bambino per lei si getterebbe nel vuoto. È l’epifania del primo amore, idealizzato, ossessivo, muto, che vivrà nella mobilità, nella motilità della lingua, prezioso scrigno di “filamenti colorati della voce”.
C’è il binomio amore e morte, rappresentato dal mito di Orfeo ed Euridice.
C’è una nonna (Nonnà) con il suo amore onnipresente e incondizionato verso il nipote che sostiene adorante e alle cui domande sempre risponde, forte della sapienza popolare.
C’è una sorta di ingratitudine e di fastidio del bambino, particolarmente ego riferito, verso quella figura così poetica e struggente nel suo “puro e semplice essere negli spazi deputati come la cucina, il lavandino, il tavolo, i fornelli, la finestra”.
C’è un esame di glottologia, altra epifania per quel bambino, ora ragazzo, riguardo al valore di colei che guarda e ascolta parlare una lingua vernacolare e apparire “come un cumulo di metallo sonoro che s’infuoca di frase in frase”. Con lei prendono voce le generazioni precedenti, attraverso suoni prebabelici. Sono le parole della terra, delle piante, degli umori, del sangue, dei lavori, “il vocabolario delle fatiche che aveva fatto, il vocabolario delle malattie gravi dei bambini e degli adulti“. È la lingua dei gesti quotidiani. Lingua dei sentimenti.
In Vita mortale e immortale della bambina di Milano (Einaudi) di Domenico Starnone ci sono anche duelli: quello a suon di spade tra due amici per contendersi l’amore della bambina di Milano; quello tra il dialetto napoletano e la lingua dei libri, tra la lingua primaria, associata al disordine e alla scompostezza, e l’italiano perfetto come quello parlato “dentro ad un grappolo compatto di cose e minuti” dalla bambina; e c’è il duello tra l’essere leggero e l’essere greve, in cui il perenne senso di angoscia di una “vita listata a lutto” viene dissimulato dallo sforzo di alleggerire il peso dell’esistenza con un tono “stabilmente divertito”.
Dopo “Lacci” Domenico Starnone firma, con una penna tagliente e seducente, un romanzo di formazione, personale e linguistica, venato di autobiografia, e racconta per voce di Mimì, Domenico, ora bambino, ora adolescente, ora giovane uomo, infine anziano, quelle schermaglie nate e sopravvissute nel magmatico ingarbuglio dell’infanzia, trascorsa nella “terribile e meravigliosa” città di Napoli degli anni Sessanta.
E se il protagonista insegue il significato di una dato sentire, di un senso esistenziale, lo raggiunge attraverso la scrittura, custode della memoria che immobilizza persone e immagini; e attraverso la letteratura che dona immortalità alle cose; e attraverso la lingua che nella sua imperfezione raggiunge la bellezza.
Vita mortale e immortale della bambina di Milano è, quindi, una narrazione sulla memoria che è labile per l’autore napoletano. In essa risiedono le nostre prime narrazioni ossia “i ricordi e le rimembranze, quelle più emozionanti e più ingannevoli”; Julian Barnes le definisce “le prime finzioni” perché “con i ricordi colmiamo buchi, assegniamo loro una logica”.
E la Vita della bambina di Milano è, così, anche un inno al potente piacere della parola «che sul momento pare giusta e poi no; il piacere che travolge il corpo anche se scrivi con l’acqua sulla pietra in un giorno d’estate, e chi se ne fotte del consenso, del vero, del falso, dell’obbligo di seminare zizzania o diffondere speranza, della durata, della memoria, dell’immortalità e tutto».