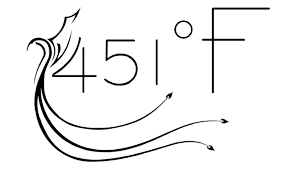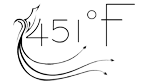Il giro dell’oca
di Erri De Luca
«Rientro nel tuo corpo.
Guarda la mia mano, si avvicina alla tua.
Ti tocco e vedi? La mia mano sta scomparendo nella tua.
Ecco il braccio e il resto di me stesso che si riassorbe in te.
Ci sono quasi, mancano solo gli occhi.
Chiudili, per favore.»
«Per un terzo di secondo le palpebre scendono a scatto sugli occhi. Succede circa quindici, venti volte ogni minuto. La vista non s’interrompe, perché il cervello unisce i punti luminosi.
Così devono fare queste righe, scorrere senza percepire i punti, gli a capo.
Il rigo da leggere ha da stare tra due battiti di ciglia.
È una sera senza corrente elettrica, un fulmine l’ha spenta, come un ruggito ammutolisce un passero. La fiamma del camino rischiara la tavola da pranzo mentre accendo una candela.»
Un battito di ciglia. Un battito d’ali. Di una soltanto, essendoci un’assenza che recuperando l’ala mancante riprende il volo. E la voce.
In questa suggestiva atmosfera dal sapore di una volta, in cui il fuoco non può essere osservato, come scrive la poetessa Mariangela Gualtieri, “senza provare uno stupore antico”, un uomo sta leggendo la favola di Pinocchio. E se nella fiaba il ciocco di legno prende vita per mano di un falegname facendone il proprio figlio, nella “realtà” l’uomo – uno scrittore napoletano – dà corpo ad una voce filiale, intavolando con essa un dialogo immaginario.
Entrambi sono adulti. Quel padre non ha mai avuto quel figlio, ma questa sera siedono al medesimo desco. Conseguenza di un lancio azzardato di dadi, è una tappa del gioco dell’oca.
«Si tira un dado e ci si sposta in un circuito a spirale.
È un gioco di percorso, le stazioni hanno nomi comuni: locanda, pozzo, prigione, labirinto, scheletro.
Il corpo è il gioco, io sono la pedina. Il tavolo, la panca di stasera sono una casella.
Ci siamo dentro e spetta a te il lancio del dado. Io mi fermo qua.»
Metafora di un percorso interiore, di giri di vite, di giri di vita, il gioco dell’oca va giocato, come la Terra attraversata secondo Erri De Luca che nel suo ultimo romanzo Il giro dell’oca (Feltrinelli) ripercorre raccontando a quello “straniero” idealizzato e materializzato le caselle e le stazioni toccate.
Il figlio ha quarant’anni anni, ha già un passato, un pregresso, ha parole e voce “in grassetto” e un piglio caustico, tagliente, interlocutorio. Una sorta di Grillo parlante e di provocatoria spalla capace di fare sviscerare quei frammenti di vita “scivolata” e divorata dal padre con cui, peraltro, palese è la somiglianza.
Attraverso l’inanellarsi di schermaglie verbali quell’esistenza viene così declinata lambendo e svolgendo i temi, autobiografici, cari all’autore: la guerra in Bosnia («La guerra è l’umanità contro se stessa, per annientamento. È volontà di rimanere in pochi, per soddisfazione di superstiti»); la rivoluzione; l’anarchia; la fede; la verità; le pratiche letterarie; l’amore («Non ti somiglio. Finora questa sera non hai tirato fuori dal tuo affezionato vocabolario neanche una volta la parola amore». «Hai ragione, provvedo. Ossigeno, ossigeno. Ossigeno allo stato puro»); Napoli («La città più fitta e densa di caratteri e persone per chilometro quadrato. Dove ognuno è se stesso con precisione da orologio e dove i disturbi della personalità sono doti e non sintomi da revisionare»); le sue passioni come la montagna; l’immenso potere della scrittura, quello delle parole. L’immensa potenza della vita.
E poi i ricordi più intimi, quelli familiari, vividi, indelebili, immoti e le abitudini allignatesi naturalmente nel tempo.
«Non celebri la festa. Per spirito di contraddizione o per deformazione rivoluzionaria di oppositore delle usanze?»
«Per il Natale si tratta di astensione dovuta a lutto.
Dalla morte di mamma lascio che passi uguale come questa sera (…).
Già dopo la morte di papà quella sera è stata ridotta al minimo.
Ora regolo a Natale il mio giorno dei morti, andando a scalare qualche roccia.
Per l’ultimo dell’anno l’astensione risale ancora più indietro e non ricordo la causa.»
E così sino a quando il dialogo volge al termine essendo quasi prossimo al “delirio”.
Ma com’è, dunque, questo padre?
Un padre incapace di pronunciare la parola mio:
«Non lo sai dire, non sai dire ‘mio’, lo hai detto piano, una veloce sillaba di passaggio.
Mio: è una dichiarazione di affetto, di certezza, di vincolo di sangue. Se sei Mio padre, devi dire Mio figlio. Fai sentire nella voce la lettera maiuscola.»
«Figlio Mio. Hai ragione, non lo so dire, non mi viene di sbattere la emme, staccarla forte dalle labbra. È una labiale imbarazzante, mi ricorda mamma, una parola che non esiste più.
Anche l’altra labiale, la pi di papà non esiste, ma non m’imbarazza.
Invecchio perdendo qualche dente e le labiali.»
Un padre secondo cui per giocare, come per vivere, occorre talvolta avere coraggio.
Un coraggio che può nascere “anche da un’imitazione”.
È un “Luftmensch” napoletano, un essere umano fatto d’aria, salvatosi da quell’elemento apparentemente inconsistente svolgendo una vita concreta forte della capacità delle parole di sostituire tutto e conferendo così corporeità alla propria esistenza.
È il resto di coloro che divenuti assenti proseguono la loro di esistenza nei suoi ricordi.
«Sono le caselle in cui sono passato e in cui ho lasciato pezzi, come succede nei traslochi.
Sono un’assemblea di me stessi diventati altri e diversi».
È un “debuttante” a vita.
È un padre privato, inconfessato. Un padre sempre lirico e sempre bruscamente struggente.