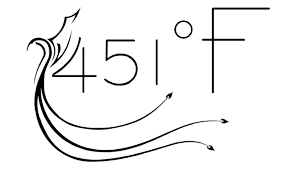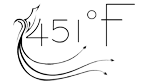All’insegna del Buon Corsiero
di Silvio D’Arzo
[Reggio Emilia 6 febbraio 1920 ~ Reggio Emilia 30 gennaio 1952]
«L’immagine del Funambolista
ad ogni modo che fra qualche ora
avrebbe attraversato il vuoto della piazza con quel suo pallido e severo sorriso d’una statua,
continuava a vivere ancora attorno a lei come i sogni di una miracolosa infanzia:
appunto con quella stessa inafferrabile,
ma insopprimibile al tempo stesso, consistenza»
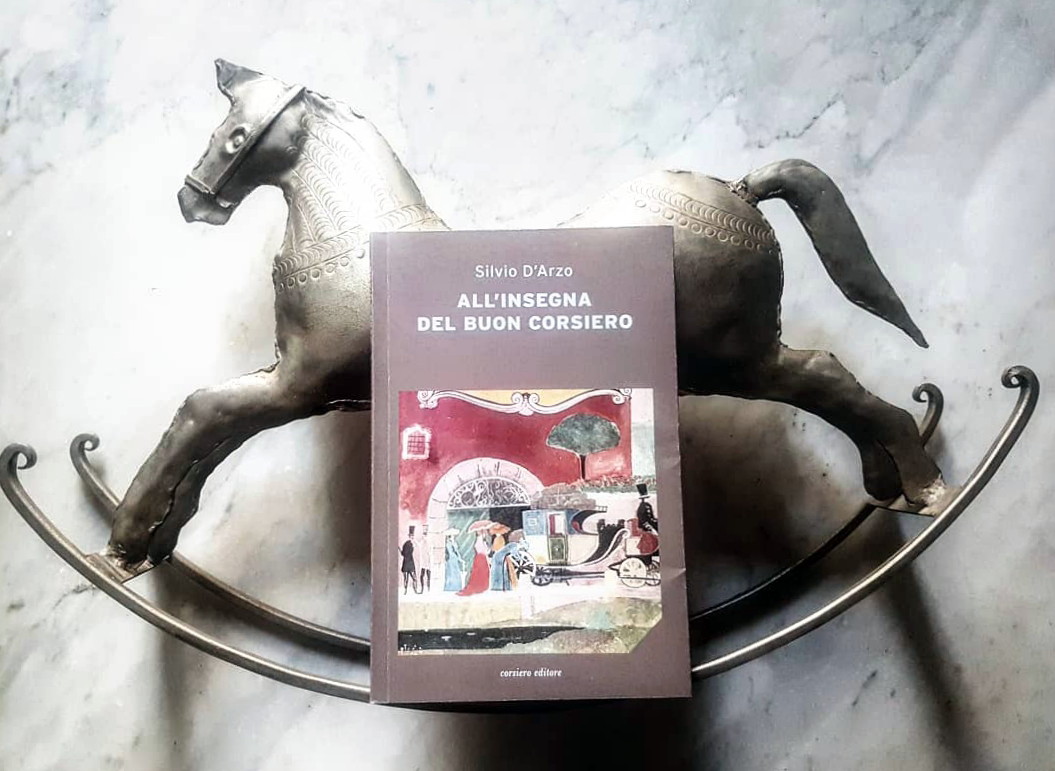
Lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli sulle pietre e il cigolio delle ruote di due carrozze.
Con questi suoni che rimandano ad un’epoca lontana, ha inizio All’insegna del Buon Corsiero di Silvio D’Arzo, al secolo Ezio Comparoni. Nato e vissuto (troppo poco) a Reggio Emilia, figura schiva, tormentata, sognatrice e sfuggente, Silvio D’Arzo si dedicò giovanissimo alla scrittura che si sostanziò sempre all’ombra di camaleontismi onomastici dettati sia da cambiamenti stilistici sia da una sorta di ritrosia verso l’identificazione geografica, ostacolo ad una condizione di libertà interiore, ma anche pudore e dolore delle proprie radici (“L’ambiente provinciale mi è così insopportabile, che voglio a tutti i costi ignorarlo ed esserne ignorato”), nonostante tra i diversi usati, lo pseudonimo con cui passò alla storia fu proprio quello – dallo stesso meno amato – derivante dal dialetto, arzan (reggiano), da cui Silvio da Reggio. Un richiamo, dunque, alle sue origini, alla sua “identità terragna”.
E nella ricorrenza della sua nascita – il 6 febbraio del 1920 – lo si vuole ricordare con l’unico romanzo pubblicato in vita. Definito dalla critica “un esempio tipico di narrazione poetica”, All’insegna del Buon Corsiero (1942), è un ironico e autoironico componimento ambientato in un Settecento (emiliano) metafisico e malizioso. Al clangore iniziale dell’arrivo delle due carrozze alla locanda Al Buon Corsiero, dove fervono i preparativi per il matrimonio della figlia del proprietario, segue uno strano silenzio, un silenzio insinuante, che riempie di tristezza e di vaghezza l’anima e che ammanta ogni essere di amarezza al sopraggiungere del “diabolico”: un Funambolo, personaggio onirico ed ambiguo, in procinto di esercitare la propria arte.
Il clima diviene, allora, rarefatto, la luce crepuscolare, il tempo sospeso.
Comportamenti (forse) prima in potenza, divengono, con sorpresa, agiti. Divengono arditi, curiosi, gelosi, violenti, in uno strano equilibrio con la provvisorietà.
Attraverso una prosa “inafferrabile” – che sarebbe divenuta oggetto di numerosi studi – lo scrittore ragazzo a 23 anni inscena un’opera teatrale sul cui palco vi sono, sì, la Marchesa, Androgeo, Mirandolina, Lauretta, Lelio, l’Uomo in Viola, tutti impegnati a tessere i fili della trama… ma a tenere la scena sono le atmosfere, le sensazioni, le suggestioni, le emozioni, le descrizioni.
Il Corsiero non è “il racconto perfetto”, come Eugenio Montale definì Casa d’altri, il titolo darziano più famoso. Il Corsiero è un racconto di dolore e fantasia. È un racconto dalla potente leggerezza dei simboli di cui è carico, che dietro una sardonica maschera bercia tutta l’insicurezza e l’angoscia dell’adolescenza.
È un omaggio tutto reggiano quello ad uno dei massimi autori del Novecento italiano: l’ultima recente edizione del romanzo si deve, infatti, a Corsiero Editore, casa editrice di Reggio Emilia che dal suo titolo ha mutuato il proprio nome.
«Era entrato, infatti, e si era diretto lentamente ma non incerto al tavolo che i servi avevano già preparato per la dama, un uomo che dai modi o dallo sguardo o, forse, infine, anche da un sesto senso si rivelò subito per il Funambolista. Le parole, intanto, che fino allora avevano reso intima e famigliare, quasi come una grande casa, la locanda, adesso si andavano lentamente spegnendo, rotolando di bocca in bocca agli avventori quasi che fossero sempre le medesime. Qualcuna, poi, che uscì sola e incerta da un sottufficiale doganiere e vagò per un attimo nella sera, un poco inquieta, parve non accennare nemmeno a cose o ricordi o sentimenti.
Quello però che maggiormente colpiva in tutto questo era la sensazione, provata per qualche istante dai presenti, che il tempo avesse cessato di scorrere attorno a loro e sopra la locanda.
Sensazione, questa, che appariva, come dire, inadeguata all’entrare in cortile del Funambolo: benché, infatti, il pensiero che un uomo ignoto e solo avrebbe la sera dopo attraversato il vuoto di una piazza, da nessun’altra magia o miracolo aiutato che non fosse la sua volontà, o, forse, il suo bastone, riempisse di qualcosa di vago e triste l’anima, tuttavia nessuno di quelli che lo videro entrare così assente e remoto nel cortile, e preceduto dalla sua lunga ombra sopra i sassi, aveva mai immaginato o sospettato di provare qualche cosa di simile al vederlo.»