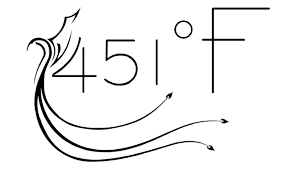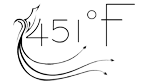Incontro con Roberto Barbolini
I colori sono quelli vividi di tele raffiguranti animali feroci; sono quelli suggestivi della Bassa Padana; quelli ferali della guerra, fondale della storia. La musica è quella danzata sulle note di una follia “autoctona” da uno stralunato corpo di ballo impegnato in una lotta per resistere ed esistere. Il primo ballerino è Antonio Ligabue, il Liga, al màt, pittore di animali e sempre in sella alla sua inseparabile Guzzi.
La storia è quella di Ligabue fandango (Corsiero Editore). Una storia che scorre sulle acque irrequiete di un luogo quasi atemporale raccontando, tra realtà e fantasia picaresca, il folle genio del Novecento italiano, quasi un epigono del “naif” Don Chisciotte e del furioso Orlando, grazie alla penna ironica ed eccentrica, dello scrittore e giornalista Roberto Barbolini.
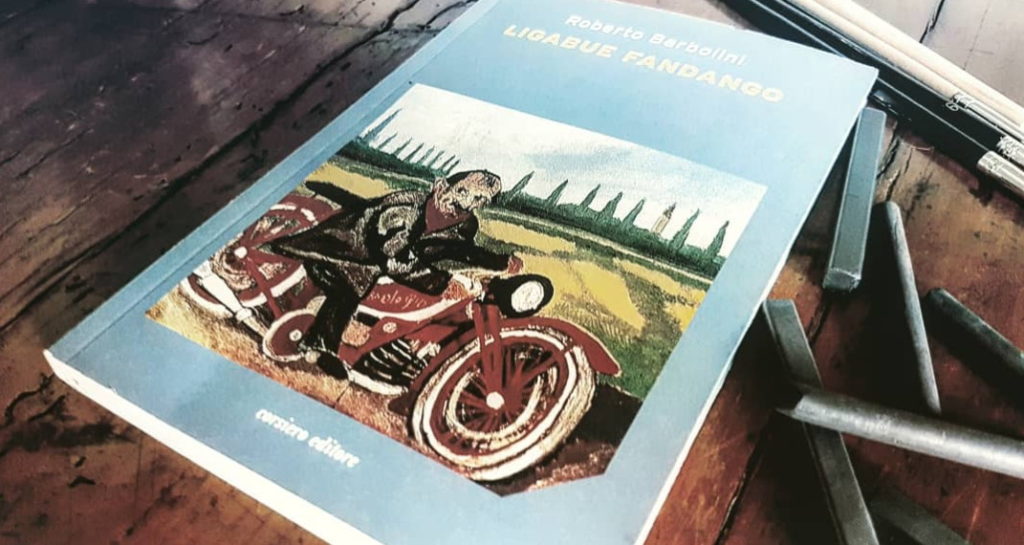
Dottor Barbolini come mai un romanzo sulla figura di Antonio Ligabue?
È una figura particolarmente suggestiva, uno dei classici interpreti della follia padana. A partire dall’Ariosto, che incarica Astolfo di recarsi sulla Luna per recuperare il senno smarrito di Orlando, attraversando tanti altri nomi della letteratura e arrivando sino ad Antonio Delfini, serpeggia una vena folle. Non è un caso che tra Colorno e Reggio Emilia, lungo il Po, ci sia un’alta concentrazione di manicomi. Ovviamente questa è una boutade!
Ad un emilianità solare, antica, molto proiettata verso il mondo, abile nel commercio e nell’industria, contraltare è sempre stata questa figura dall’emilianità “euforica”. Pensiamo alla Casa d’altri di Silvio D’Arzo con il suo mondo agro e con la durezza dell’Appennino appartenente anche a Guido Cavani. E poi ci sono questi matti di Pianura, i lunatici di Cavazzoni e quelli della Voce della Luna di Fellini. Sicuramente, quindi, c’è qualcosa che aleggia nello scorrere di quelle acque, generativo della vena di follia di artisti e personaggi. In questa araldica ideale Ligabue si colloca con una doppia veste, rappresentando da un lato il genius loci, il massimo, quindi, dell’emilianità, quanto di più padano ci sia, dall’altro un apolide, cresciuto all’estero, quindi il forestiero, lo straniero e come tale emarginato e perseguitato. La sua follia è maturata in questo spazio sociale.
Quanto c’è di corrispondente alla realtà relativamente al contesto storico e alla figura di Ligabue?
È presente una bizzarra aneddotica corrispondente al Ligabue reale come il particolare di percuotersi il cranio con una pietra per rendere il naso aquilino. Tuttavia, la storia è assolutamente inventata. Quindi, ovviamente, non è né una ricostruzione storica del personaggio né tantomeno una celebrazione della sua arte. In questa storia fantasmagorica e delirante Ligabue entra come personaggio e come testimone di tutta questa follia serpeggiante. Follia in quanto forma di salute profonda, perché ciò che è veramente poi folle è il mondo attorno a lui con la guerra, la Repubblica Ducale che macina, una sorta di crasi tra i fumi delle ceramiche della zona di Sassuolo e i campi di concentramento.
Il suo è un romanzo picaresco, ariostesco. I riferimenti all’Orlando Furioso sono numerosi come i nomi, la Luna, l’ondivagare, la follia. Cosa accomuna Orlando a Ligabue?
Una vanvera in chiave picaresca unita al gusto cavalleresco dell’avventura, al desiderio della ricerca di un’impresa che distolga dalla agonia di una realtà grigia e opprimente. Una realtà che, forse, è quella dipinta dal vero Ligabue. Il suo amore per il circo, per questo mondo sgargiante, è l’opposto della vita che viveva in sella alla motocicletta, il suo cavallo da paladino.
Nel titolo cita il Fandango, lo stile musicale dell’omonima danza spagnola. Quale danza si vede, quale musica si sente nel suo romanzo?
Ho strizzato scherzosamente l’occhio al Ligabue rocker che nomina il Fandango in alcune sue vecchie canzoni nelle quali, inoltre, vivono personaggi come Walter il mago, figure di un mondo di provincia non lontane da quello in cui Antonio Ligabue visse.
Inoltre, come la musica spagnola ha un ritmo crescente, così anche io porto la trama di questa vanvera padana sino ad una bagarre. C’è un prologo con un senso di fine del mondo seguito da una voce corale e, come in una danza, ognuno interpreta la propria parte cedendo il passo, il testimone della narrazione, all’esecutore successivo. Il ballerino principale è Ligabue. E tutto diviene, sul finale, una sorta di sarabanda, stravolto in una specie di frenesia di un mondo impazzito. È la frenesia di Ligabue stesso, pazzo, per sua ammissione, perché il mondo è pazzo. Ma, naturalmente, essendo lui un perdente non può che soccombere, come poi accadde nella realtà. Non c’è,comunque, alcuna pretesa di fare coincidere il Ligabue del romanzo con il Ligabue del reale. Il vero Ligabue, infatti, non deve presentare la carta d’identità dello storico della pittura. È anche il simbolo di una libertà. Posso dire, quindi, “Ligabue c’est moi“, come Flaubert fece con Madame Bovary.

Una dose di sana follia è insita nell’essere umano. Samuel Beckett diceva: “Si nasce tutti pazzi, alcuni lo restano”. È d’accordo?
Occorre che questa follia diventi una forma di lucidità. Nel libro la struttura, che sembra mimare il caos assoluto, è sempre infinitamente più ordinata dell’autentico caos costituito dalla realtà. L’entropia aumenta continuamente nel mondo reale, in qualsiasi struttura che voglia mimare la complessità e anche irrazionalità profonde.
Il fondale del racconto è quello della guerra. È una guerra interiore quella combattuta da Ligabue lunga un’intera vita?
La biografia di Ligabue è molto particolare. Combatte un’intera vita una guerra interiore che è il suo corrispettivo della guerra vera che si svolge attorno a lui.
Emerge dal romanzo l’assurdità della guerra…
Emerge, sì. La guerra esaspera i pregi ma anche i difetti: il massimo della viltà e capacità di tradimento dell’uomo, in Ligabue il massimo della sua follia. È, comunque, una forza che travolge i destini e contro la quale può agire soltanto un fare che non sia teso al potere ma alla pienezza. L’arte, la pittura, la letteratura, sono l’antidoto, benché sempre perdente rispetto alla furia del mondo. Quindi, sì, non è una visione ottimistica.
Come mai la scelta di affrontare vicende drammatiche con uno stile ironico e grottesco?
Nonostante nel libro vengano sciorinati diversi orrori, il ritmo trascinante grottesco e picaresco sfocia nel comico. In questa dimensione che cerca di non prendere sul serio neppure le tragedie, ho sempre ravvisato la salvezza. Gli ebrei raccontavano storielle antiebraiche anche nei lager. Il nostro Guareschi nel campo di concentramento inscenava spettacolini per regalare un sorriso ai compagni. Lì ha scritto il Diario clandestino…
Anche nelle situazioni più atroci c’è l’esigenza, quindi, di recuperare questa dimensione che ci addomestica nelle realtà difficili da comprendere e da accettare. L’ironia, il comico, il non drammatizzare sono sempre stati una mia cifra stilistica, cosa che ho sempre cercato di adottare anche nella mia vita.
Cos’è per lei la follia?
Questo è il libro della follia. Un grano di follia è indispensabile per vivere, essendo l’uomo incessantemente impegnato nella ricerca del senso della vita che risulta, però, sempre rinviato, irraggiungibile. Prescindendo dagli obiettivi mondani come il successo o l’amore, chi raggiunge veramente quel traguardo? Le domande non hanno risposta e a pensarci si diventa matti.
La follia è il Romanzo. Il Romanzo moderno inizia con il Don Chisciotte di Cervantes: con un folle che emula i libri antichi. Ma è una follia bella che lentamente contagia il mondo circostante in favore di un’utopia cavalleresca, perché quello di cui si era innamorato era un mondo già tramontato. Tuttavia, ciò che fa quando trasforma un bacile da barbiere in un elmo da cavaliere è quanto facciamo tutti noi quando scriviamo, leggiamo, sogniamo, guardiamo un film, studiamo. C’è sempre una trasfigurazione che è follia.
Ognuno in fondo scrive il romanzo della propria vita grazie ad un granello di follia.
Schopenhauer diceva che ognuno di noi è il protagonista del proprio romanzo ed è una comparsa del romanzo dei libri altrui. C’è, dunque, una follia generalizzata e collettiva per cui essa consiste forse nel riconoscersi talmente folli da controllarla, scrivendo, leggendo, obiettivandola in qualche modo. Purtroppo, poi, se deborda diventa una patologia e c’è chi ne rimane preda come Ligabue.
Nella storia illustra “uno stralunato bestiario umano” tra cui anche un coccodrillo. Parla di cervello rettiliano e scrive che “dentro ad ognuno di noi c’è un coccodrillo”.
Cosa rappresenta in realtà questo animale?
Oltre ad essere un affettuoso omaggio al mio amico Guido Conti che ha scritto la raccolta di racconti intitolata Il coccodrillo sull’altare, questo animale rappresenta una bestialità molto arcaica. Mentre la pioggia di rane iniziale è qualcosa di bizzarro ma anche gioioso, quest’altro anfibio è duro, scaglioso. È l’immagine del male.

Nel libro scrive: “La vita è un gran palo di tortura”. Domanda secca: uomini o animali?
Non posso rispondere in modo secco. Scegliere tra uomini e animali è complicato.
L’importante è che l’uomo non smarrisca la propria animalità. Non dobbiamo uccidere l’animale che è in noi. Non deve soltanto essere l’uomo razionale che crede di aver abolito ogni legame con la natura. L’animale è l’altro, è qualcos’altro da noi, qualcosa di cui, però, abbiamo nostalgia e con la quale ci è sempre più difficile rapportarci. Pensando alla scienza, al post darwinismo, quanto più ci dicono che siamo dei bonobo evoluti tanto più, invece, diveniamo creature artificiali assomigliando a dei robot.
Fortunatamente, per ora, gli esseri umani come noi credo che si trovino in una situazione limbica intermedia dove la bestia non è totalmente cancellata dentro di noi.
Comunque, più conosco gli esseri umani più amo le bestie. Questo lo devo dire.
La prima edizione di Ligabue Fandango risale a circa vent’anni fa…
Esattamente. L’ho scritto in un periodo di grandi problemi di salute, fortunatamente superati, e forse questo romanzo prefigurava quei drammi personali. È un libro dove incombe qualche cosa, c’è un tentativo di sfuggire alla morte, di esorcizzarla.
Lei si occupa di Patafisica. Quanto è presente questa scienza nel suo romanzo?
Sono membro di un Collegio Vitellianense di patafisica e Soprintendente Perpendicolare del Collegio di Patafisica, Ordine della Grande Giduglia.
In quanto scienza delle soluzioni immaginarie, creata da Alfred Jarry, la patafisica è un sapere un po’ lunatico, una parodia dello scientismo che ci circonda. È un divertimento, ma anche qualcosa in più essendo il Collegio di Patafisica collegato all’Officina di letteratura potenziale di Raymond Queneau di cui fece parte, tra gli altri, anche Italo Calvino.
Tornando alla sua domanda, qualcosa del grottesco di Ubu, personaggio di Alfred Jarry, forse è presente nel libro. Tendo, tuttavia, a non fare mai derivare ciò che scrivo da una gabbia preconcetta.
Probabilmente è da Ligabue che divento patafisico. La patafisica è, infatti, una grande libertà.
Ligabue fandango intende trasmettere un preciso messaggio?
No, nessun messaggio, altrimenti non avrei scritto un romanzo pazzo come Ligabue fandango, ma qualcosa di diverso come un saggio su Ligabue, oppure uno studio sulla follia padana. Per me il romanzo non è una linea retta che procede da A a B, né deve necessariamente dimostrare qualcosa, o peggio ancora renderci migliori. È, invece, un mettersi in gioco attraverso il linguaggio, un cammino che non puoi fare a meno di compiere anche se non sai dove ti porterà, e, in definitiva, una scommessa su un senso che rimane elusivo e sfuggente, sempre un passo oltre l’ultima pagina.
Come il senso delle nostre vite, del resto.