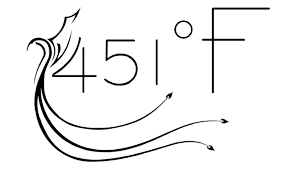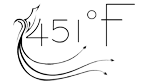«Posso non essere andato…dove intendevo andare, …ma penso di essere finito…dove avevo bisogno di essere», diceva Douglas Adams.
Così… qualunque sia il movente dell’approccio ad un libro,
ci si può trovare, durante o al termine della lettura, in dimensioni e luoghi impensati,
non voluti ma, anche inconsapevolmente, necessari.
Buona lettura…e buon viaggio.

«Viviamo in città superaffollate. Abbiamo violato, e continuiamo a farlo, le ultime grandi foreste e altri ecosistemi intatti del pianeta, distruggendo l’ambiente e le comunità che vi abitavano. […] Uccidiamo e mangiamo gli animali di questi ambienti. Ci installiamo al loro posto, fondiamo villaggi, campi di lavoro, città, industrie estrattive, metropoli. Esportiamo i nostri animali domestici, che rimpiazzano gli erbivori nativi. Facciamo moltiplicare il bestiame allo stesso ritmo con cui ci siamo moltiplicati noi. In tali condizioni è facile che gli animali domestici e semidomestici siano esposti a patogeni provenienti dall’esterno (come accade quando i pipistrelli si posano sopra le porcilaie) e si contagino tra di loro. In tali condizioni i patogeni hanno molte opportunità di evolvere e assumere nuove forme capaci di infettare gli esseri umani tanto quanto le mucche o le anatre. Molti di questi animali li bombardiamo con dosi profilattiche di antibiotici e di altri farmaci, non per curarli ma per farli aumentare di peso e tenerli in salute il minimo indispensabile per arrivare vivi al macello, tanto da generare profitti. […] Commerciamo in pelli, contrabbandiamo carne e piante, che in certi casi portano dentro invisibili passeggeri patogeni. Viaggiamo in continuazione, spostandoci da un continente all’altro […]. Mangiamo in ristoranti dove magari il cuoco ha macellato un porcospino prima di pulire i nostri frutti di mare. Visitiamo i mercati in India, paesini pittoreschi in Sudamerica, fattorie nei Paesi Bassi, grotte pieni di pipistrelli in Africa orientale, ippodromi in Australia – e ovunque respiriamo la stessa aria, diamo da mangiare agli animali, tocchiamo tutto, diamo la mano ai simpatici abitanti del luogo. Poi risaliamo su un bell’aeroplano e torniamo a casa. Cambiamo il clima del globo con le nostre emissioni di anidride carbonica. Siamo tentazioni irresistibili per i microbi più intraprendenti, perché i nostri corpi sono tanti e sono ovunque. Tutto ciò che ho appena scritto si può rubricare sotto la voce “ecologia e biologia evolutiva delle zoonosi”. Le circostanze ambientali forniscono opportunità agli spillover. L’evoluzione le coglie, esplora le potenzialità e dà gli strumenti per tramutare gli spillover in pandemie.»
È alquanto eloquente questo passo di Spillover (Adelphi). Scritto nel 2012 è di un’attualità sconcertante. Lungi da teorie negazioniste e complottistiche, è profetico e, giustamente, allarmante. Ha lanciato un monito disatteso dall’umana intelligenza che, inveteratamente, ha perseverato nelle sue abitudini colonizzatrici ed egoistiche.
David Quammen, scrittore e divulgatore scientifico statunitense, per anni ha seguito scienziati “cacciatori di virus” nella foresta pluviale del Congo, nelle grotte della Malesia, nei mercati cittadini della Cina, nelle fattorie australiane, per dare contezza, in questo saggio letterario, della storia delle grande epidemie, della loro evoluzione, della loro nascita. Ha raccontato la logica dello Spillover, ossia del salto di specie. Ha illustrato la concreta possibilità che quel balzo, da animale a uomo, accada laddove quest’ultimo violi, distrugga e si appropri sempre più di spazi naturali e animali. Spillover è un avvincente viaggio nella comprensione della realtà presente e nella salvaguardia di quella futura perché «Siamo davvero una specie animale, legata in modo indissolubile alle altre, nelle nostre origini, nella nostra evoluzione, in salute e in malattia… Il virus siamo noi.»
«(…) e le case rosa, azzurre e gialle e i roseti e i gelsomini e gerani e cactus e Gibilterra da ragazza dove ero un Fior della montagna sì quando mi mettevo la rosa tra i capelli come facevano le ragazze andaluse o me ne metterò una rossa sì e come mi ha baciato lui sotto le mura moresche così ho pensato oh bè va bene lui come un altro e poi gli ho fatto segno con gli occhi di chiedermelo di nuovo sì e allora lui mi ha chiesto se volevo sì dì di sì mio fior della montagna e io prima lò abbracciato sì e me lo son tirato addosso in modo da fargli sentire i miei seni tutti un profumo sì e il suo cuore sembrava impazzito e sì ho detto sì voglio Sì.»
Opera divisiva, ostica e rivoluzionaria, Ulisse, l’Odissea moderna di James Joyce, a distanza di sessant’anni dalla prima edizione italiana, torna in una nuova traduzione integrale basata su quella degli Oxford World Classics del 1922 e arricchita da un apparato di note indispensabile per comprendere appieno la ricchezza della scrittura.
È sempre il 16 giugno del 1904 e le sue 24 ore si svolgono in quelle 1.060 pagine trasposte, ora, per La nave di Teseo da Mario Biondi, scrittore e rinomato traduttore.
L’errare, in una Dublino omerica, di Leopold Bloom – novello Odisseo – e la miriade di personaggi che incontra, tra cui Stephen Dedalus e Molly Bloom, rivive attraverso i molteplici registri narrativi e l’utilizzo da parte dell’autore irlandese della tecnica del flusso di coscienza. Un coacervo di pensieri, di parole, di assenza di logica temporale accompagnano la tensione di un’esistenza imprigionata fisicamente e psicologicamente, incapace di ribellarsi alle convenzioni, evidenziando la perdita di senso, la disgregazione del sé e la crisi dell’uomo d’oggi.
«Il cambiamento che si è prodotto nella mente del Bengala è stato repentino e straordinario, come se il Gange avesse toccato le ceneri dei sessantamila figli di Sagar, che nessun fuoco poteva incendiare né altre acque potevano bagnare e rendere modellabili come argilla vivente. Le ceneri senza vita del Bengala si sono improvvisamente risvegliate e hanno proclamato: “Eccomi!”.
Ho letto da qualche parte che nell’antica Grecia c’era uno scultore capace di infondere la vita nelle immagini create dalle sue mani. Se il suo miracolo contemplava lo sviluppo della forma che precede la vita, mi chiedo dove sia l’unità della forma nel cumulo di sterili ceneri che rappresentano il Bengala. […] Le nostre ceneri devono essere scivolate tra le dita del Creatore, e una volta cadute a terra il vento le ha disperse.»
Romanzo d’amore e di politica. Storia di identità, di emancipazione femminile e di libertà di un Paese è La casa e il mondo del poeta, scrittore e filosofo indiano Rabindranath Tagore nella nuova traduzione di Sabina Terziani per Fazi Editore.
Nella sua lirica mistica, il premio Nobel per la letteratura nel 1913, racconta per voce dei tre monologanti protagonisti, Nikhil, Sandip e Bimala, di rivalità sentimentali, di conflitti interiori, del movimento indipendentista indiano Swadeshi contro la dominazione britannica di inizi Novecento – epoca della quale delinea un fedele spaccato del mondo indiano – ; narra di quando il “mondo” varca le mura domestiche, di contrapposizioni tra modernità e tradizione, di contrasti tra materialismo e idealismo. Di contrasti tra la casa e il mondo.

«Insieme ad altri ha immaginato una nuova figura di insegnante all’interno di una scuola rinnovata, ha lavorato alla costruzione di un diverso modello di genitore, più consapevole e vicino ai bambini e alle bambine dell’Italia degli anni della grande e complessa trasformazione; ha guardato alle novità senza gli occhiali del passato, accogliendole, criticandole, ma mai condannandole in quanto tali. Infine, ha voluto fortemente condividere con gli altri le sue scoperte sulla fantastica, cardine tra la fantasia e la ragione, in un libro d’oro e d’argento, la Grammatica della fantasia. Un gioco, ma – come ha scritto lui stesso – “il gioco, pur restando gioco, può coinvolgere il mondo”. Rodari ha inventato un nuovo modo di guardare il mondo ascoltandolo fino alla fine, con il suo “orecchio acerbo” e così facendo ha portato l’elemento fantastico nel cuore della crescita democratica dell’Italia repubblicana.
Rodari è stato un intellettuale. E se un intellettuale è una persona in grado di dare un senso a quello che sta sotto gli occhi di tutti, rompendo lo specchio della duplicazione tenendo a mente il passato e il futuro, allora Gianni Rodari è stato un meraviglioso intellettuale.»
A cento anni dalla sua nascita e a quaranta dalla sua scomparsa Vanessa Roghi, storica e autrice di documentari, rende omaggio ad uno degli scrittori più tradotti in tutto il mondo, svincolandolo dall’etichetta critica e stereotipata che lo voleva “soltanto” un autore per bambini. Lezioni di fantastica – Storia di Gianni Rodari (Laterza) è una biografia che ripercorre la vita, ricca e complessa, non solo dell’ideatore di Favole al telefono, de Il Libro degli errori, delle Filastrocche in cielo e in terra, ma anche di colui che, per le sue invenzioni linguistiche, venne accostato a Raymond Quenau, per la raffinatezza a Roland Barthes, per la disponibilità al fantastico a Carroll e a Barrie, per l’intento di “liberare gli uomini dalla schiavitù di essere utili” ai surrealisti.
E il ritratto che si delinea è quello di un grande intellettuale dalla vita colma: di giornalismo, di politica, di passione educativa, di scrittura, di letteratura. Una vita colma di grandi “insiemi”, gli stessi di uno degli esercizi di fantasia più noti da lui inventato.
«È mai esistita in passato un’epoca in cui era così complicato vivere in modo semplice, spontaneo, sincero?
Nella società le masse stanno prendendo il sopravvento e sono sempre più numerosi coloro che vanno in cerca di leader dalla voce forte, che deridono – quando non vedono con astio – la passione di chi porta avanti un pensiero indipendente, e che cercano di escludere il diverso.
Venticinque anni fa guardavo a questo libro con preoccupazione, chiedendomi per chi potesse avere un valore, a parte per me e per le donne essenzialmente simili a me, ma adesso che mi sono avvicinata all’età della nonna di Mai, voglio riproporlo, nel mio piccolo, ancora una volta.
Allora, buon viaggio.
Ti prego di raggiungere, senza fare distinzioni, coloro che potrebbero aver bisogno di te, che siano giovani o vecchi, donne o uomini, e di affiancarli, di sostenerli con tutta la forza che hai, di incoraggiarli.
E di sussurrare loro queste parole: non abbiamo una voce forte, ma possiamo comunque trasmettere il nostro messaggio, parlando tra noi a bassa voce.»
Un piccolo gioiello della narrativa nipponica, pluripremiato in patria, tanto semplice ed essenziale quanto vero e profondo, è il libro d’esordio, nel 1994, di Kaho Nashiki.
Un’estate con la Strega dell’Ovest (Feltrinelli) è quella che Mai, una ragazzina con l’avversione per la scuola, trascorre, per volere dei genitori, con la nonna nella sua casa immersa nella “magica” natura incontaminata delle Alpi giapponesi. Dagli effettivi poteri soprannaturali, l’anziana signora inizierà la nipote ad un serrato addestramento alle pratiche magiche, consistente in un percorso di crescita personale, di cambiamento e consapevolezza. Disciplina, impegno e costanza sono gli ingredienti della pozione per affrontare e superare gli ostacoli e le avversità della vita, ripetendosi sempre che “qualunque cosa accada, non è una ferita mortale”.
«Viveva una volta, negli Stati Uniti d’America, presso una serie di indirizzi temporanei, un uomo itinerante originario dell’India, di età avanzata e dalle facoltà intellettive in declino, che a causa della sua passione per i programmi televisivi più insulsi aveva trascorso troppo tempo davanti allo schermo nella luce gialla di squallide stanze di motel fino a riportare, per questo, danni celebrali di un tipo molto particolare. Divorava avidamente trasmissioni del mattino e del pomeriggio, talk show serali, sitcom, film biografici, sceneggiati di ambientazione ospedaliera, telefilm polizieschi, serie su vampiri e zombie, i drammi delle casalinghe del New Jersey, di Beverly Hills e di New York, le storie d’amore e le beghe di principesche eredi di imperi alberghieri e di sedicenti sovrani orientali, le gozzoviglie di individui resi celebri da felici nudità, i quindici minuti di notorietà accordati a giovani donne che vantavano un nutrito seguito sui social media perché si erano fatte rimuovere delle costole per poter sfoggiare le forme impossibili della Barbie (…) e ancora: gare di canto, gare di cucina, gare di progetti imprenditoriali (…).»
Si chiama Ismail Smile (Quichotte), è un gentile commesso viaggiatore per un’industria farmaceutica. Non è divoratore di romanzi cavallereschi, ma di maratone trash televisive. Vive in un tempo squilibrato, in un’epoca chiamata DG (Dopo Google), comandata da una plebe asservita allo smartphone e in cui dilaga una piaga generalizzata: l’overdose da farmaci a base di oppio. È a conoscenza dell’imminente fine del Mondo, che tenta di salvare, ed è innamorato di una popolare star della TV, Salma (novella Dulcinea), per conquistare la quale, in compagnia del figlio immaginario, Sancho, intraprende un picaresco e tragicomico viaggio attraverso l’America.
È questa la trasposizione moderna, deliberatamente caotica, del Don Chisciotte di Cervantes attuata con un’operazione di realismo magico da Sulman Rushdie.
Con Quichotte (Mondadori) l’irriverente e geniale scrittore anglo-indiano racconta, attraverso le gesta di un folle “Don”, un Paese sull’orlo del collasso morale e spirituale e in cui forte è lo scollamento dalla realtà.
«America che fine hanno fatto il tuo ottimismo, le tue nuove frontiere, i tuoi semplici sogni alla Norman Rockwell? Mi tuffo nelle tue tenebre, America, affondando nel tuo cuore come un coltello, ma la lama della mia arma è la speranza.»

«Sono un ragazzo di ventidue anni, che a volte si comporta come immagina facciano gli uomini, potrei chiamarmi Anton o Adam o Gideon, il nome che di volta in volta mi suona meglio, e sono francese o tedesco o greco, ma albanese mai, e cammino esattamente come mi ha insegnato mio padre, a passi larghi e cadenzati, so bene come tenere alti petto e spalle, la mascella serrata a garantire che nessuno invada il mio territorio. E in momenti come questi la donna dentro di me arde sul rogo. (…) A volte sono una ragazza di ventidue anni, che si comporta come le pare. Amina o Anastasia, il nome non è importante, mi muovo nel modo in cui ho visto muoversi mia madre, i miei tacchi sfiorano appena il suolo e non contraddico mai gli uomini. Mi trucco il viso, mi inciprio le guance, mi disegno il contorno degli occhi passando attentamente matita, ombretto e mascara, metto lenti a contatto blu per sentirmi rinascere, e in quel momento l’uomo dentro di me non brucia, ma mi accompagna in giro per la città.»
Bujar parla in prima persona rivelando la propria storia. Racconta i luoghi abbandonati, quelli raggiunti, Tirana, Roma, Madrid, Berlino, Helsinki, sino al Nuovo Continente. Racconta le differenti vite che può interpretare attingendo dettagli dalle persone amate e indossando la pelle di generi diversi: «nessuno è tenuto a rimanere la persona che è nata, possiamo ricomporci come un nuovo puzzle».
Ma un continuo ventaglio di sentimenti e di emozioni si agita e si reitera ad ogni cambio d’abito nel corso di una fuga da se stesso e di una ricerca incessante di se stesso. Le transizioni (Sellerio) è il potente e commovente romanzo con cui il giovane autore finlandese Pajtim Statovci propone, con sensibilità innovativa, una profonda riflessione letteraria sull’identità.
«Chi crede in Dio, può sentirsi improvvisamente abbandonato, come accade perfino a Gesù sulla croce, può vedere la realtà sparire intorno a lui e sotto di lui. (…) Il Danubio, invece, anche soltanto quello superiore, c’è, non sparisce, non promette ciò che non mantiene, non abbandona, scorre fedele e verificabile, non conosce l’azzardo della teologia, le perversioni ideologiche, le delusioni dell’amore. È là, tangibile, e verace, e il devoto che gli dedica la propria esistenza la sente fluire in armoniosa e indissolubile unione col fluire del fiume.»
Non è un romanzo né un saggio, Danubio (Garzanti) è un viaggio personale, istruttivo, appassionato e seduttivo che Claudio Magris, insieme con alcuni amici, compie dalle sorgenti del corso d’acqua sino al Mar Nero. Nel farlo ripercorre non soltanto la propria vita, ma mostra, attraverso l’esplorazione dei Paesi bagnati dal fiume blu e la rievocazione di personaggi ad essi legati – Céline, Kafka, Heidegger, Baudelaire, Canetti…- anche come la cultura rappresenti un’esperienza esistenziale. Nelle sue riflessioni, nelle sue annotazioni, nei suoi aneddoti, la complessità delle culture e dei popoli Mitteleuropei danno l’abbrivio alla ricerca del senso della vita e della storia. Nelle pagine dell’illustre germanista e scrittore triestino, intimamente legato al suo Danubio, risuona l’incanto delle cose nel loro esistere più immediato, ma anche di quel “sentire lontano” che risiede dietro ad esse.
«Il viaggio è forse sempre un cammino verso quelle lontananze che splendono rosse e viola nel cielo della sera, oltre la linea del mare e dei monti, nei paesi sui quali sorge il sole che da noi tramonta.»
«Io non so dirti se hanno più problemi, o se ne hanno meno, o se sono più bravi o più inferociti. Quello che so, però, è che il mondo ha bisogno di dissenso…(…)
Non so che ruolo abbiano e avranno nella storia i giovanissimi che oggi protestano, non riesco a dire se stiano combattendo battaglie di retroguardia, già vinte o finte, o inutili. Intendo dire che non so quale ruolo avranno nell’evolversi della storia, ma ribadisco che è proprio di questo tipo di dissenso che abbiamo bisogno. Io non credo nelle ricette eterodirette per la felicità, non credo che la salvezza per tutti stia per forza nell’uscire di casa a diciott’anni. (…) Il fatto è che la nostra società non è pronta ad accoglierli. Viviamo in una società completamente senza welfare, che affida alla costruzione utile di macchiette sminuenti come il bamboccione, la zitella che non fa figli fino a tardi, la primipara attempata la soluzione di tutte le sue carenze.»
Chi sono, come sono i giovani d’oggi? Quelli tra i diciotto e i trent’anni. Studenti, lavoratori, disoccupati. Quelli che si trasferiscono all’estero per inseguire un sogno, o che rischiano la vita per altruismo nelle zone di guerra. Quelli che comodamente ascoltano podcast, sempre iperconnessi digitalmente e che fanno l’aperitivo con gli amici. Giovani dalle menti brillanti o opache. Ambiziosi o apatici.
Elena Becchi nella sua indagine in questo spazio generazionale, un po’ confuso e smarrito, trascendendo stereotipi, generalizzazioni e classificazioni, li definisce Solisti, laddove la solitudine è intesa come libertà da vincoli, da preconcetti, come autonomia di scelta d’azione o di inazione, come libertà di autodeterminarsi. E tra di loro figurano anche ragazzi come Giulio Regeni, Valeria Solesin, Antonio Megalizzi, Silvia Romano, Greta Thunberg.
Ne I Solisti – La meglio gioventù (Aliberti / E-stories) la giornalista reggiana esplora, così, questa infinita orchestra dialogando con personaggi illustri come Michela Marzano, Pablo Trincia, Marino Niola, Francesco Cavalli, Irene Soave e Fabio Geda.
Non emerge un solo ritratto, ma una molteplicità di raffigurazioni. Non una sola esecuzione, ma un’infinita polifonia in cui nessun suono o voce è stonato. La complessità umana prevede, infatti, il pluralismo identitario, si esprima esso in personalità forti o pacate, appagate o querule, in gregari o leader, ma sempre capaci di scegliere autonomamente. I Solisti sviluppano forza individualmente convergendola poi in comunione di intenti e di azione, certamente con pochi punti di riferimento, ma con il fermo dovere di ricostruire la società.