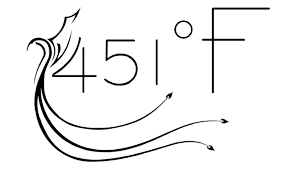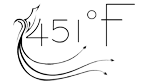«La guerra toglie a chiunque ne sia coinvolto due diritti fondamentali: il diritto di vivere e il diritto di non uccidere», scrive Vasilij Grossman.
Sono spesso gli scrittori, le scrittrici. Sono la letteratura, la narrativa, la saggistica. Spesso sono le parole appese, palesate o nascoste, berciate o sussurrate o alluse tra le righe di centinaia di pagine. Riflessioni. Risposte. Pensieri. Senza velleità risolutorie, ma inevitabilmente obbligano a fermarsi, a pensare, a tirare il fiato che è venuto meno.
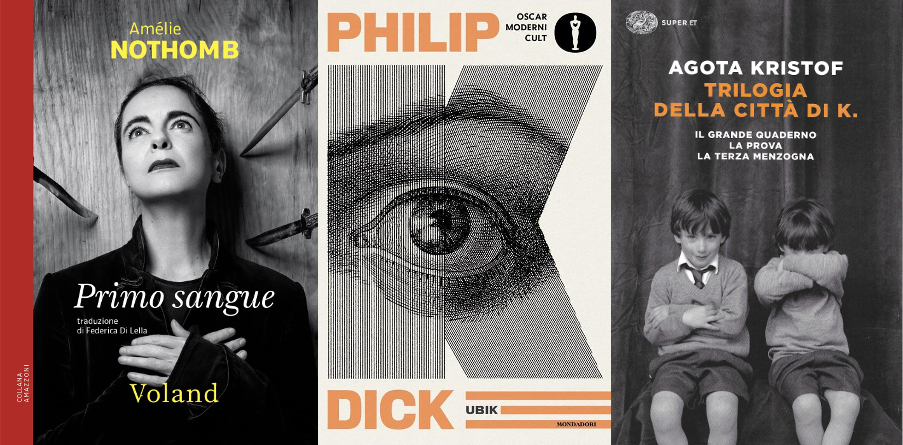
«Io sono Ubik. Prima che l’universo fosse, io ero. Ho creato i soli. Ho creato i mondi. Ho creato le forme di vita e i luoghi dove abitano; spostandole e muovendole come più mi aggrada. Vanno dove dico io, fanno ciò che io comando. Io sono il verbo e il mio nome non è mai pronunciato, il nome che nessuno conosce. Mi chiamano Ubik, ma non è il mio nome. Io sono. Io sempre sarò». Scritto nel 1966 da uno dei padri della narrativa fantascientifica, Philip K. Dick con UBIK propone una lettura della società attraverso un racconto quasi filosofico in cui la realtà è come l’illusione, in cui la morte è un momento di transizione della coscienza. Ci sono agenzie prudenziali che utilizzano inerziali per contrastare l’attività di telepati e precog nelle operazioni di spionaggio industriale, c’è un viaggio sulla Luna, c’è un progressivo viaggio nel tempo, c’è la semivita.
Ubik è «un tracollo psichico, la corsa erratica di una cavia da laboratorio resa pazza da un esperimento dal protocollo incomprensibile, un trionfo delle tenebre, del caos e dell’entropia. Un libro basilare, stupefacente, vitale. Un’esperienza di lettura unica e traumatica, un incubo e nello stesso tempo una rivelazione».
Perfette sono le parole di Emmanuel Carrère che, trovandosi a scrivere le prefazioni per le nuove edizioni italiane di Mondadori – bellissime le vesti grafiche – dei cinque romanzi più importanti di Dick, chiosa così: «Ecco fatto. Ho detto quelle due o tre cose che mi ero ripromesso di dirvi e ora questa prefazione giunge al termine. Vi trovate sulla soglia del libro. Il libro di un uomo che ha visto Dio? Il libro di un uomo cui le droghe hanno fulminato il cervello? In ogni caso, varcare questa soglia equivale ad avventurarsi in un territorio dove non siete mai stati. Non avete idea di quello che vi attende. Io sì, ma adesso vi pianto in asso. Me ne vado in punta di piedi, e vi lascio soli. Se avete paura, avete ragione ad averne.
Coraggio, adesso.
Entrate».
«Per decidere se è Bene o Non Bene, abbiamo una regola molto semplice: il tema deve essere vero. Dobbiamo descrivere ciò che vediamo, ciò che sentiamo, ciò che facciamo.
Ad esempio, è proibito scrivere: “Nonna somiglia a una strega”; ma è permesso scrivere: “La gente chiama Nonna la Strega”.
Allo stesso modo, se scriviamo: “L’attendente è gentile”, non è una verità, perché l’attendente può essere capace di cattiverie che noi ignoriamo. Quindi scriveremo semplicemente: “L’attendente ci regala delle coperte”.
Scriveremo: “Noi mangiamo molte noci”, e non: “Amiamo le noci”, perché il verbo amare non è un verbo sicuro, manca di precisione e di obiettività. “Amare le noci” e “amare nostra Madre”, non può voler dire la stessa cosa. La prima formula designa un gusto gradevole in bocca, e la seconda un sentimento.
Le parole che definiscono i sentimenti sono molto vaghe, è meglio evitare il loro impiego e attenersi alla descrizione degli oggetti, degli esseri umani e di se stessi, vale a dire alla descrizione fedele dei fatti.»
Fiaba cattiva, cattivissima, storia di formazione, racconto di “genere di confine”, “Trilogia della città di K.” di Agota Kristof viene annoverata tra i capolavori della letteratura contemporanea. In quella che Giorgio Manganelli definisce “una prosa di perfetta, innaturale secchezza, una prosa che ha l’andatura di una marionetta omicida”, l’autrice ungherese ambienta in un luogo imprecisato dell’Europa dell’Est, bombardato e minacciato dall’occupazione nemica, la storia di due gemelli il cui sguardo cinico e lucidamente insensibile e atarassico, li porta ad annotare tutto quanto li circonda su di un quaderno. “Il grande quaderno” è, infatti, il titolo del primo romanzo che compone l’opera di Kristof, seguito da “La prova” e da “La terza menzogna” nei quali i due fratelli, separati da un differente destino, si ritrovano. Si assiste ad un capovolgimento dei fatti, ad un irriconoscimento dei personaggi, che induce ad una vertigine tanto affascinante quanto inquietante, mentre si declinano i temi del doppio, del labile confine tra realtà e finzione e della denuncia sociale e politica.
«Mi portano davanti al plotone di esecuzione. Il tempo si dilata, ogni secondo dura un secolo più del precedente. Ho ventotto anni.
Di fronte a me, la morte ha la faccia di dodici fucilieri. La consuetudine vuole che una delle armi sia caricata a salve. Così che ognuno possa ritenersi innocente dell’omicidio che sta per essere perpetrato. Dubito che oggi quella tradizione sia stata rispettata. Nessuno di questi uomini sembra aver bisogno di una possibilità di innocenza.
Una ventina di minuti fa, quando ho sentito gridare il mio nome, ho capito immediatamente cosa significava. E giuro che ho tirato un sospiro di sollievo. Visto che stavano per uccidermi, non avrei più avuto il dovere di parlare».
Vincitore ex equo con “Punto di fuga” di Mikhail Shishkin del premio Strega Europeo 2022, “Primo sangue” (Voland) è un omaggio che Amélie Nothomb tributa al padre, scomparso nel 2020. Quasi una catarsi è stato per la scrittrice belga dare la parola in prima persona a Patrick Nothomb, nato nel 1937, orfano a soli otto mesi del padre e cresciuto in una delle famiglie più aristocratiche (ed eccentriche) del Belgio. Racconta la sua rocambolesca vita a partire dall’infanzia, quando ancora sognava di diventare un calciatore o un capostazione o un poeta, sino all’età adulta quando, invece, il destino gli riserva la carriera diplomatica, per cui si troverà nel 1964 in Congo a salvare 1.450 ostaggi, tra i quali anche se stesso, dopo quattro mesi di trattative con i ribelli. La vista del sangue è il suo tallone d’Achille, “anche quello di una bistecca o di una tartarre”, che lo fa letteralmente svenire. “Primo sangue” è una storia familiare dove le parole sono tagliate col coltello, e dove c’è ironia, commozione e potenza.

«Il mare è profondo, cambia colore e sembra che respiri. È un bene per noi avere il mare, perché a volte i giorni passano senza che accada un bel niente e allora guardiamo il fiordo che diventa blu, e poi verde, e poi scuro come la fine del mondo.
Ma la vita fugge in ogni direzione e si conclude a metà frase, e allora non c’è niente di meglio che svegliarsi presto la mattina e guardare la superficie del mare, e lasciar scorrere il tempo».
Un paesino dell’Islanda di 400 abitanti, atavicamente legati alla loro terra, le cui vite esemplificano tutte le sfaccettature del sentire e dell’agire umano, da quelle più vivide a quelle più livide.
La luce, infinita, dell’estate le illumina. Il bagliore, magico, delle stelle le incoraggia.
«A volte nei posti piccoli la vita diventa più grande».
In questa atmosfera quasi sospesa dove non trovano luogo né chiesa né cimitero, prende le mosse “Luce d’estate ed è subito notte” (Iperborea) di Jón Kalman Stefánsson. In una mescola di poesia, ironia ed umorismo, l’autore islandese tesse, qui, le maglie di un romanzo corale dal ritmo lento, languido, nostalgico eppure seducente ed evocativo, che induce a riflettere e a interrogarsi sul “Perché viviamo?”.
«Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né contentezza; e mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua, e appena tornati qua, subito hanno voglia di scappar via. Tu te ne andrai da un luogo all’altro, come se fuggissi di prigione, o corressi in cerca di qualcuno; ma in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse che si mischiano nel tuo sangue, perché il tuo sangue è come un animale doppio, è come un cavallo grifone, come una sirena. E potrai anche trovare qualche compagnia di tuo gusto, fra tanta gente che s’incontra al mondo; però, molto spesso, te ne starai solo. Un sangue-misto di rado si trova contento in compagnia: c’è sempre qualcosa che gli fa ombra, ma in realtà è lui che si fa ombra da se stesso, come il ladro e il tesoro, che si fanno ombra uno con l’altro.»
Procida è la capitale della cultura italiana 2022: “La cultura non isola” è il claim. E proprio sull’isola calabrese, Elsa Morante ha ambientato il romanzo, “L’isola di Arturo”. Storia di formazione “epica”, introspettiva, una narrazione metaforica e simbolica, L’isola di Arturo narra il passaggio dall’età adolescenziale all’età adulta, la perdita dell’innocenza, dunque, del protagonista che porta il nome di una stella, “la luce più rapida e radiosa della figura di Boote nel cielo boreale”. Orfano di madre e in conflitto con il padre, Arturo vive sulla sua isola tra sogni, scoperte e disincanti, leggendo libri su grandi condottieri e facendo di ogni sua giornata un’avventura.
«Per uno nato e cresciuto a mare, il sale è quello sulla pelle asciugata dopo il tuffo. Preferisco tenermelo addosso, come una protezione. Mi piace il suo odore.
Credo che ce ne sia nell’aria, nel vento del maestrale, nei fulmini, nelle briciole delle comete, nell’arcobaleno. Nella scrittura sacra entrava in ogni offerta sull’altare. […] Il cibo ha una storia spaventosa, eroica, miracolosa. La scrittura sacra contiene narrazioni di provviste dal cielo. La parola fame è stata più temuta della parola guerra, della parola peste, di terremoti, incendi, inondazioni. Si è ammansita presso di noi l’ultima virata di bordo del secolo, permettendo insieme alla medicina la prolunga inaudita dell’età media. Si è costituita una scienza dell’alimentazione. Lentamente le porzioni si sono trasformate in dosi, le etichette forniscono l’apporto in calorie. Sono di un’epoca alimentare precedente a questa, basata sulla scarsa quantità e varietà. Mi è rimasto in bocca un palato grezzo, capace di distinguere il cattivo dal buono, ma povero di sfumature intermedie. Ho le papille del 1900».
Sono storie di bocconi e di bevande di un palato antico, storie di cibo familiare quelle che Erri De Luca porta in tavola con “Spizzichi e bocconi” (Feltrinelli).
Aneddoti che veicolano gli odori e i sapori di un mondo fatto di cibo, di memoria, di poesia. La famiglia, il lavoro nei cantieri, la militanza politica, l’amore per la montagna, le osterie – “stanze di popolo”, mescola di generazioni – l’onnipresente Napoli, danno tutti l’abbrivio a narrazioni. Sono odori e sapori di un mondo lontano, in parte perduto. Anche sapori per i quali pratica l’astinenza, come quello della Parmigiana di melanzane. Un lutto culinario.
Il biologo nutrizionista Valerio Galasso accompagna, in queste pagine, l’autore napoletano associando ad ogni piatto un sano comportamento alimentare. «Con lui imparo cosa fa il cibo, al di là della sazietà».

«La cosa da ricordare è questa: questa è soprattutto una storia d’amore. Non ve lo scordate mai.
Ma ora che l’abbiamo detto, conosciamoci meglio: sono le tre di notte. Sono le tre di notte e io sono da qualche parte nel Midwest, in uno di quegli stati piatti dove tutti sembrano più simpatici del dovuto. Sono in albergo. Nel corridoio. Sto correndo. No, a dire il vero il mio è proprio un allungo. Sto correndo come un pazzo nel corridoio di un albergo del Midwest. Ho già detto che sono nudo? Ecco, sono nudo. E mi inseguono».
Vincitore del National Book Award 2021, “Che razza di libro!” di Jason Mott, nella trasposizione italiana, per NN Editore, porta un titolo che tradisce, in parte, le tematiche trattate: la discriminazione, il pregiudizio, i sogni, la speranza, l’illogicità del pensiero umano, la percezione di sé, l’identità.
Due i protagonisti: uno scrittore americano che durante il tour promozionale del proprio romanzo – intitolato “Che razza di libro” – fra interviste, avventure amorose ed esperienze ad alto tasso alcolico, incontra “Nerofumo“, un ragazzino dalla pelle nerissima, un colore “nero impossibile” e “dalle profondità di inchiostro“, dotato – pare – del dono dell’invisibilità, quale antidoto contro le brutalità del mondo. Un viaggio nel viaggio. Un libro nel libro. Un’opera metaletteraria dai colpi di scena, dal ritmo incalzante e catalizzante. Jason Mott è commovente e feroce, è esilarante e tragico.
«Quando ti guardi allo specchio, ti piace ciò che vedi?»
«Cerco di non guardarmi. Credo che molte persone come me facciano così».
«Quando dici “persone come me”, che cosa intendi?”».
«Avendo fin dalla nascita goduto quasi di ogni vantaggio, uno dei pochi privilegi negati a Benjamin Rask fu quello di un’ascesa eroica: la sua non fu una storia di tenacia e perseveranza, o l’epopea di una volontà inscalfibile capace di forgiare per sé un destino aureo pur partendo da una manciata di scorie».
Chi è Benjamin Rask, uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, il magnate della finanza divenuto milionario dopo alcune speculazioni seguite al crollo in Borsa del 1929? Hernan Diaz nel rispondere a questa domanda ambienta negli anni Cinquanta un romanzo che esplora, come mai nessuno prima, il labirintico mondo del denaro, del capitale, della ricchezza.
In realtà “Trust” (Feltrinelli) dà contezza della vita di Benjamin Rask attraverso quattro testi, quattro registri, quattro generi, quattro voci, quattro punti di vista differenti. Il primo è un romanzo dentro al romanzo che racconta la storia di uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti e del rapporto con la moglie; il secondo è un memoir sulla realtà di ciò che il romanzo ha romanzato; il terzo è un altro memoir che chiarisce la relazione tra i primi due ed, infine, il quarto consiste in un documento ritrovato che dà una completezza a tutto.
Delle numerose accezioni che il termine “trust” possiede, Diaz considera quella economica, intesa come monopolio, e quella morale, intesa come fiducia, inducendo, così, il lettore a domandarsi in quale narratore e racconto riporre la propria fiducia.
Un romanzo metaletterario e originalissimo che allude a come la verità possa essere una merce da comprare.
«Nella sua irripetibilità, nella sua unicità risiede l’anima di ogni singola vita – la libertà. Il riflesso dell’Universo nella coscienza umana è alla base della forza dell’uomo, ma la vita diventa felicità, libertà, valore supremo solo quando l’uomo esiste come un mondo che mai potrà ripetersi nell’infinità del tempo. Solo quando riconosce negli altri ciò che ha già colto dentro di sé l’uomo assapora la gioia della libertà e della bontà».
Capolavoro della letteratura del Novecento, “Vita e destino” (Adelphi) di Vasilij Grossman, giornalista e scrittore sovietico di origine ebraica, nasce come seconda parte – scritta tra il 1950 e il 1960 e pubblicata nel 1980 – di una dilogia insieme con “Stalingrado”, di recente uscita nelle librerie. Con questo monumentale romanzo (1000 pagine) Grossman catapulta il lettore nella Seconda Guerra Mondiale, attorno al 1942 e 1943, dove se da un lato assiste allo scontro tra due potenze, tra la Germania e l’Unione Sovietica, tra due ideologie, il nazismo e il comunismo, dall’altro fa la conoscenza di un groviglio di personaggi, reso ancora più disorientante dall’utilizzo dei patronimici. Ognuno è portatore di una propria vita, strettamente ancorata al corso della Storia, ognuno possiede un singolo e irripetibile destino. Ma il vero protagonista dell’opera è il male, è l’insensatezza della guerra, vissuta in prima persona da Grossman come corrispondente, sono il suo orrore, la sua ferocia, la sua meschinità e mistificazione, ed è la follia del pensiero imposto dai totalitarismi che uccide l’essenza della realtà.
Coprotagonista è, tuttavia, la forza della libertà che si leva, è l’irriducibilità dell’umanità, ed è la vita. Celebrata, sempre e comunque.