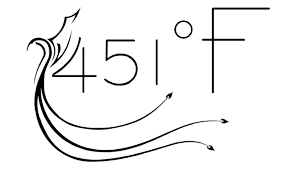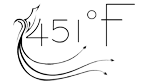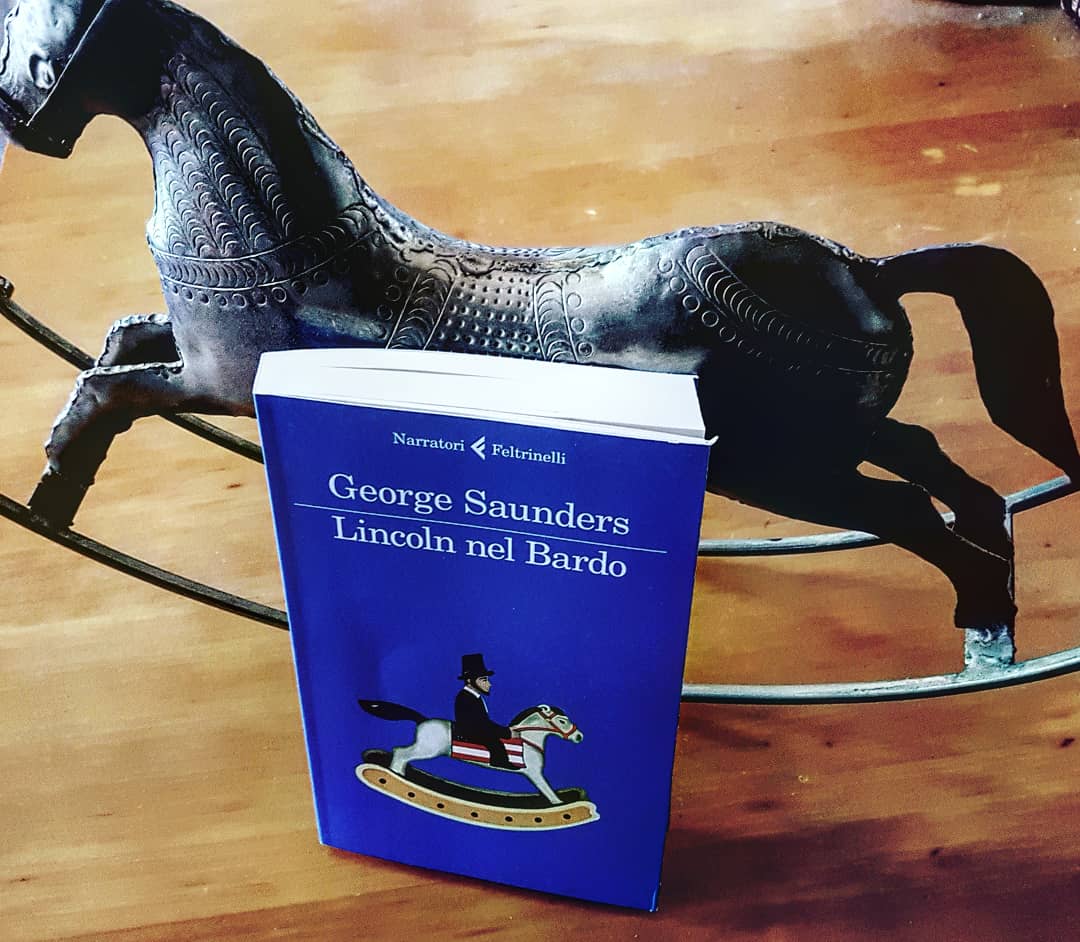“Non mi restava altro che andare.
Anche se le cose nel mondo erano ancora con me.
Come, per esempio: un branco di bambini che arrancavano sotto una spruzzata obliqua, di neve decembrina; un cerino spartito amichevolmente sotto un lampione storto da una collisione; l’orologio ghiacciato di un campanile visitato dagli uccelli; l’acqua bagnata dopo un temporale di giugno.
Perle, stracci, bottoni, la frangia di un tappeto, la schiuma di birra.
Qualcuno che ti manda gli auguri; qualcuno che si ricorda di scriverti; qualcuno che si accorge che non si per nulla a tuo agio.
Il rosso micidiale di un piatto d’arrosto sanguinolento, il palmo che sfiora una siepe mentre corri in ritardo in una scuola che sa di gessetti e legna accesa.
(…)
Una gocciolina nell’occhio che offusca un campo di stelle; la spalla che ti duole dove ci hai appoggiato lo slittino; scrivere il nome del tuo amore sulla brina di una finestra con il dito guantato.
Allacciarsi una scarpa; fare il fiocco a un pacchetto; una bocca sulla tua; una mano sulla tua; il giorno che finisce; il giorno che comincia; la sensazione che ci sarà sempre un altro giorno.
Addio, ora devo dire addio a tutto quanto.
Il matto che urla di notte;il crampo al polpaccio in primavera; il massaggio al collo in salotto, il sorso di latte a fine giornata.
(…)
La bacinella di porcellana insanguinata balla a faccia ingiù sul pavimento di legno; l’ultimo respiro incredulo che non smuove la buccia d’arancia lì in mezzo a quel sottile strato di polvere estiva, il coltello fatale appoggiato nel panico sul traballante corrimano di casa, e poi lasciato cadere (buttato) da mia madre (cara madre) ( con la morte nel cuore) nel lento Potomac color cioccolato.
Niente di tutto questo era reale; niente era reale.
Tutto era reale; straordinariamente reale; infinitamente caro.
Questo e tutte le cose iniziarono dal nulla, erano latenti in un immenso brodo di energia, ma poi abbiamo dato loro un nome, le abbiamo amate e , in questo modo, le abbiamo portate alla luce.
E adesso dobbiamo perderle.
Ecco che cosa vi dico, cari amici, prima di andarmene, con questa istantanea esplosione di pensiero, a un luogo in cui il tempo rallenta e poi si ferma, dove potremo vivere per sempre in un singolo istante.”
roger bevins III
Altrove.
Che magnifica parola.
Apre scenari. Concede possibilità. Asseconda credo.
È soggettiva per alcuni, oggettiva per altri.
L’altrove dipinto da George Saunders in Lincoln nel Bardo è un coacervo esulcerante, berciante, disperato e talvolta comico di anime parlanti ognuna una lingua ed una storia proprie, fondendosi, confondendosi ed assumendo forme inconsuete e curiose.
Il limbo è la loro trappola e la consapevolezza non appartiene a tutte.
È il febbraio del 1862 e Willie, il figlio dell’allora Presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, scompare causa una fatale malattia. Il luogo deputato per le esequie è scontato, quanto accadrà in quello stesso luogo, nel corso di una sola illune e allucinata notte, tutt’altro.
C’è un qui, un là, c’è un prima, un durante e un dopo.
Ci sono le “forme malate”, non i defunti, le casse da malato, non le casse da morto. C’è l’agghiacciante rumore della fiammata connessa al fenomeno della materialuceradiante.
C’è uno scampolo di storia, l’amore incondizionato e il dolore lacerante per quanto, si dice, essere contro natura, che permettono alla lingua immaginifica dell’autore statunitense di parlare alla testa e al cuore.
Lincoln nel Bardo (Feltrinelli)
George Saunders, Amarillo, 2 dicembre 1958.
“Poi mio padre mi tocco la fronte con la sua.
Caro figliolo, disse, tornerò. te lo prometto.”
willie Lincoln